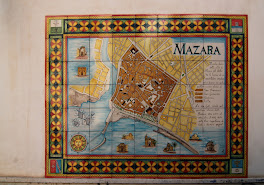Da casa a Castepletroso (338 km)
Ci siamo: dopo un anno intero di stop, finalmente siamo pronti a ripartire per un viaggio in camper! Quest’anno è stato molto particolare, di certo nessuno si sarebbe mai immaginato di non poter organizzare neanche una piccola uscita primaverile. Del resto, l’estate è off limits perché il lavoro non mi permette ferie lunghe, perciò il nostro modo di ritrovarci, io e i miei super genitori, è sempre lo stesso: viaggi in camper in primavera o autunno. Peraltro, sono ben due anni che non metto piede sul nostro Arca, dato che lo scorso settembre abbiamo noleggiato un Ford negli Stati Uniti e la primavera precedente, essendo già a lavoro, mi sono persa l’Andalusia!
 Stavolta il viaggio sarà tutto italiano (anche perché tra mascherine, quarantene e contagi covid... all’estero dove vuoi andare?!) con qualche novità: una nuova coppia di colleghi camperisti (con cui ci vedremo domenica a Maratea) e, soprattutto, il nuovo arrivato di casa, Mercurio. Dovremo riorganizzare spazi ed abitudini poiché non ci saremmo mai sognati di portare un gatto in viaggio con noi (Penelope, la nostra precedente gatta, era abituatissima a stare per i fatti suoi e a casa in attesa del nostro ritorno, con qualcuno che badasse a lei che era comunque autonoma), ma Mercurio è troppo piccolo e vivace per restare da solo. E quindi eccolo qui, con il suo guinzaglietto, il trasportino, la sabbietta, la ciotola. Ci abitueremo alla convivenza reciproca in uno spazio così limitato?
Stavolta il viaggio sarà tutto italiano (anche perché tra mascherine, quarantene e contagi covid... all’estero dove vuoi andare?!) con qualche novità: una nuova coppia di colleghi camperisti (con cui ci vedremo domenica a Maratea) e, soprattutto, il nuovo arrivato di casa, Mercurio. Dovremo riorganizzare spazi ed abitudini poiché non ci saremmo mai sognati di portare un gatto in viaggio con noi (Penelope, la nostra precedente gatta, era abituatissima a stare per i fatti suoi e a casa in attesa del nostro ritorno, con qualcuno che badasse a lei che era comunque autonoma), ma Mercurio è troppo piccolo e vivace per restare da solo. E quindi eccolo qui, con il suo guinzaglietto, il trasportino, la sabbietta, la ciotola. Ci abitueremo alla convivenza reciproca in uno spazio così limitato?Imbocchiamo quindi l’autostrada e ci fermiamo da qualche parte in Abruzzo per il pranzo. Pianificando l’itinerario, ci balza all’occhio che siamo nei pressi di Roccascalegna e dell’omonima famosa fortezza medievale del XI Secolo, arroccata su uno spuntone di roccia che domina il borgo.

 L’ingresso costa 4,00 € a persona, una cifra ragionevole se si considera che la ragazza all’ingresso ci spiega dettagliatamente la storia di questa fortezza: costruita nel 700 d.C. a scopo difensivo, modificò la sua struttura nel corso dei se coli fino a diventare residenza baronale nel Settecento.
L’ingresso costa 4,00 € a persona, una cifra ragionevole se si considera che la ragazza all’ingresso ci spiega dettagliatamente la storia di questa fortezza: costruita nel 700 d.C. a scopo difensivo, modificò la sua struttura nel corso dei se coli fino a diventare residenza baronale nel Settecento.

Riprendiamo la marcia e raggiungiamo, con una bellissima luna piena che sorge, Castelpetroso. Per l’esattezza, saliamo lungo una stradina circondata da boscaglia che porta al Santuario della Santissima Addolorata, una basilica in stile neogotico che ricorda, molto in piccolo, il Parlamento di Budapest (non a caso, quest’ultimo è una delle massime rappresentazioni del neogotico in Europa), ma con i tetti turchesi (verde rame, direi) anziché rosso porpora. E’ già illuminata quando ci fermiamo nel parcheggio adiacente (gratuito e consentito ai camper) e scendiamo per qualche foto in semi-notturna.

Il freddo è pungente e si infila nelle ossa (siamo a cica 800 metri sul livello del mare, ma molto nell’entroterra... praticamente a metà tra una costa e l’altra), quindi il giro è estremamente breve. Ci penseremo domani!
Giovedì 01 ottobre – km 107128
Da Castelpetroso a Matera (337 km)
Stamattina, dopo il gatto che ha iniziato a passeggiare alle 5.30 del mattino, siamo risvegliati dallo scampanaccio del santuario alle 6.45, una condanna! Per il resto, la notte è trascorsa abbastanza tranquilla.
Facciamo un giro mattutino del santuario, per ammirarlo sotto una luce nuova (non prima di aver fatto sgambare Mercurio con i dovuti problemi del caso!) ed entriamo: la struttura è essenziale, colonne larghe e lavorate con capitelli a sorreggere le volte.



Ci si aspetterebbe, forse, un interno più “carico”, mentre invece è molto semplice, privo di orpelli tipici del neogotico. Girarci attorno alla luce del sole, comunque, è un piacere per gli occhi!

 Dal parcheggio dei bus, in pochi minuti raggiungo Piazza Vittorio Veneto, porta d’ingresso all’ex Capitale della Cultura. A nulla serve recuperare una piantina del centro storico all’ufficio turistico, benché la mia idea sia quella di un rapido tour quantomeno armonico.
Dal parcheggio dei bus, in pochi minuti raggiungo Piazza Vittorio Veneto, porta d’ingresso all’ex Capitale della Cultura. A nulla serve recuperare una piantina del centro storico all’ufficio turistico, benché la mia idea sia quella di un rapido tour quantomeno armonico.  Arrivo sulla piazza del Duomo in tempo per il tramonto e per lo spettacolo unico della città vista dal punto più alto possibile. Pian piano si fa buio, si accendono le lucine dei vicoli, una dopo l’altra, e continuo a scattare foto ad una città che d’improvviso si trasforma in un enorme presepe, meraviglioso da qualsiasi punto lo si osservi. Vorrei restare per ore, ma non posso, quindi mi avvio al parcheggio della stazione dei bus e recupero i miei. Ci spostiamo quindi all’Area Camper Matera, 3 km fuori dal centro. Senza elettricità né carico/scarico, tre persone (tenendo conto anche della bassa stagione) spendiamo 15,00 € per la notte, con navetta per Matera a/r inclusa nella tariffa.
Arrivo sulla piazza del Duomo in tempo per il tramonto e per lo spettacolo unico della città vista dal punto più alto possibile. Pian piano si fa buio, si accendono le lucine dei vicoli, una dopo l’altra, e continuo a scattare foto ad una città che d’improvviso si trasforma in un enorme presepe, meraviglioso da qualsiasi punto lo si osservi. Vorrei restare per ore, ma non posso, quindi mi avvio al parcheggio della stazione dei bus e recupero i miei. Ci spostiamo quindi all’Area Camper Matera, 3 km fuori dal centro. Senza elettricità né carico/scarico, tre persone (tenendo conto anche della bassa stagione) spendiamo 15,00 € per la notte, con navetta per Matera a/r inclusa nella tariffa.Per stasera ci fermiamo, e domani torniamo in città.
Venerdì 02 ottobre - Km 107465
da Matera a Fardella (141 km)
Anche stamattina ci svegliamo all’alba, ma la nostra navetta per il centro di Matera (a/r incluso nella tariffa della sosta notturna) non parte prima delle 9.15. Sono molto cordiali da queste parti: le due sorelle che gestiscono l’area camper ci omaggiano anche di una pagnotta “di benvenuto” e sono molto gentili. Il babbo compra un pezzo di formaggio materano dall’omino che vende i caciocavalli con l’apetta e il direttore dell’area sosta, il signor Michele, è ormai un pensionato ma molto attento alle richieste e ai bisogni dei camperisti: si vede, insomma, che il suo lavoro lo fa con passione.
 Il giro riparte da dove ho iniziato ieri, e cioè Piazza Vittorio Veneto. Festosa e movimentata, in ogni momento del giorno e dell’anno, questa piazza è considerata il centro della città, luogo di incontro e di passeggiata, spesso attraversata da mercatini e invasa da ritrattisti in un’atmosfera di brio. Da qui si può partire anche per dare inizio ad un percorso sotterraneo scavato nella roccia, noto come Palombaro, un insieme di grandi strutture utilizzate per la raccolta delle acque piovane.
Il giro riparte da dove ho iniziato ieri, e cioè Piazza Vittorio Veneto. Festosa e movimentata, in ogni momento del giorno e dell’anno, questa piazza è considerata il centro della città, luogo di incontro e di passeggiata, spesso attraversata da mercatini e invasa da ritrattisti in un’atmosfera di brio. Da qui si può partire anche per dare inizio ad un percorso sotterraneo scavato nella roccia, noto come Palombaro, un insieme di grandi strutture utilizzate per la raccolta delle acque piovane. Poco più in là, il primo Belvedere, che ieri non avevo visto, mentre il sole dritto in faccia illumina gli angoli di questo profondo paese tra le cavità rocciose, svelando piccoli cortili fioriti, scale adornate di piante e panni stesi.
Poco più in là, il primo Belvedere, che ieri non avevo visto, mentre il sole dritto in faccia illumina gli angoli di questo profondo paese tra le cavità rocciose, svelando piccoli cortili fioriti, scale adornate di piante e panni stesi.Lascio i miei per dedicarmi ad un paio di attività alternative con la scusa di gironzolare nei sassi: la ricerca delle altre installazioni di Salvador Dalì (la prima, l’Elefante Trampoliere, troneggia da un lato all’inizio di Via San Biagio) ed il Ponte Tibetano sul fiume Gravina, che collega le due sponde della Gola della Gravina nel Parco Nazionale delle Murge Materane.
 Non manco nemmeno oggi, quindi, di perdermi felicemente nelle viuzze di questa città unica nel suo genere. Nota con il nome di "Città dei Sassi”, è conosciuta in tutto il mondo per gli storici rioni “Sassi”, che costituiscono la parte antica della città e ne fanno una delle città ancora abitate più antiche al mondo. Scavati e costruiti a ridosso della Gravina di Matera, la profonda gola che divide il territorio in due, i Sassi di Matera sono composti dal Sasso Barisano, il Sasso Caveoso, e al centro la Civita, sperone roccioso che separa i due Sassi, sulla cui sommità si trovano la Cattedrale ed i palazzi nobiliari. Insieme formano l'antico nucleo urbano di Matera, dichiarato dall'UNESCO "paesaggio culturale". I Sassi sono stati riconosciuti nel 1993 come patrimonio dell’umanità e anzi, sono stati il primo sito dell'Italia meridionale a ricevere tale riconoscimento. Per capire meglio cosa siano davvero questi sassi, bisogna fare un notevole salto indietro nel tempo. Sono un insediamento urbano derivante dalle varie forme di civilizzazione ed antropizzazione succedutesi nel tempo. Da quelle preistoriche dei villaggi del periodo neolitico, all'habitat della civiltà rupestre dell’800 d.C, dalla civitas di matrice normanno-sveva dell’anno Mille, con le sue fortificazioni, alle successive espansioni rinascimentali e sistemazioni urbane barocche, ed infine dal degrado igienico-sociale dell’Ottocento e di metà Novecento, fino all'attuale recupero iniziato a partire dalla legge del 1986.
Non manco nemmeno oggi, quindi, di perdermi felicemente nelle viuzze di questa città unica nel suo genere. Nota con il nome di "Città dei Sassi”, è conosciuta in tutto il mondo per gli storici rioni “Sassi”, che costituiscono la parte antica della città e ne fanno una delle città ancora abitate più antiche al mondo. Scavati e costruiti a ridosso della Gravina di Matera, la profonda gola che divide il territorio in due, i Sassi di Matera sono composti dal Sasso Barisano, il Sasso Caveoso, e al centro la Civita, sperone roccioso che separa i due Sassi, sulla cui sommità si trovano la Cattedrale ed i palazzi nobiliari. Insieme formano l'antico nucleo urbano di Matera, dichiarato dall'UNESCO "paesaggio culturale". I Sassi sono stati riconosciuti nel 1993 come patrimonio dell’umanità e anzi, sono stati il primo sito dell'Italia meridionale a ricevere tale riconoscimento. Per capire meglio cosa siano davvero questi sassi, bisogna fare un notevole salto indietro nel tempo. Sono un insediamento urbano derivante dalle varie forme di civilizzazione ed antropizzazione succedutesi nel tempo. Da quelle preistoriche dei villaggi del periodo neolitico, all'habitat della civiltà rupestre dell’800 d.C, dalla civitas di matrice normanno-sveva dell’anno Mille, con le sue fortificazioni, alle successive espansioni rinascimentali e sistemazioni urbane barocche, ed infine dal degrado igienico-sociale dell’Ottocento e di metà Novecento, fino all'attuale recupero iniziato a partire dalla legge del 1986.

Questo ponte andava fatto, ma ammetto che il senso di vertigine mi spezza le gambe, anche se l’altezza non era eccessiva! Risalgo dallo stesso lato dissestato dal quale sono scesa e riprendo il mio cammino. A causa del contingentamento per il covid, perdo la visita alla Casa Cava e la prossima è alle 12:30, ma non farei in tempo poiché ho la navetta alle 13:00.
 Preferisco comunque continuare felicemente a perdermi nelle vie e nelle terrazze bianche di Sasso Caveoso, adornate con cactus, fichi d’india e fiori che sanno d’estate.
Arrivo al Belvedere Giovanni Pascoli, da dove ancora si scopre un magnifico scorcio di Matera, e poco dopo, in Piazza San Francesco, trovo anche il Pianoforte surreale di Dalì!
Preferisco comunque continuare felicemente a perdermi nelle vie e nelle terrazze bianche di Sasso Caveoso, adornate con cactus, fichi d’india e fiori che sanno d’estate.
Arrivo al Belvedere Giovanni Pascoli, da dove ancora si scopre un magnifico scorcio di Matera, e poco dopo, in Piazza San Francesco, trovo anche il Pianoforte surreale di Dalì!Raggiungo i miei alla fermata del bus, e poco dopo arriva la navetta a riportarci all’area sosta. Sgambatella per Mercurio prima di pranzo e anche dopo. Il sole però è cocente nonostante l’arietta, quindi preferiamo non farlo accaldare più del dovuto. Lasciamo l'area di sosta pronti a proseguire la nostra marcia, estremamente soddisfatti del trattamento ricevuto e della giornata che stiamo trascorrendo, dell'ospitalità di questa gente, del calore dei loro modi e della loro estate che non vuole finire. Prima di lasciarci completamente Matera alle spalle, un'ultima scappatella al belvedere in cima alla strada di Contrada Murgia Timone, dal quale Matera si scorge dall’altro lato, quello meno comune, di Via Madonna delle Virtù.


 Lungo la strada che passa davanti al paese c’è un piccolo parcheggio, dove ci fermiamo per qualche minuto. Una grossa scritta campeggia sul muraglione:
Lungo la strada che passa davanti al paese c’è un piccolo parcheggio, dove ci fermiamo per qualche minuto. Una grossa scritta campeggia sul muraglione:



Le case diroccate e franate danno però un senso di angoscia, come vedere i danni del terremoto, e obiettivamente ci lasciano un po’ di magone, quindi ci allontaniamo.
Lungo la strada che ci porta alla nostra meta ultima, ci fermiamo all’Eurospin per un mini rifornimento, ed è già buio quando raggiungiamo l’area di sosta camper di Fardella, nome che a noi fa tantissima simpatia. Soprattutto, ieri abbiamo chiamato casualmente il proprietario, Gennarino, con il numero trovato su internet e ci è sembrato talmente cortese che non potevamo non fermarci. Come volevasi dimostrare, appena parcheggiamo si palesa con una vaschetta di uva fragola e fichi bianchi come “benvenuto”. Qualche minuto di chiacchiere, poi si congeda e ci lascia alla nostra stanchezza.
Sabato 03 ottobre – km 107606
da Fardella a Paola (184 km)
 La mattinata inizia presto come sempre. Dopo la colazione, mentre monitorniamo Mercurio al guinzaglio che sgamba nel prato ordinatissimo della nostra piccola area di sosta, ci intratteniamo in chiacchiere con una coppia di camperisti con bimbo al seguito, che attacca bottone affascinato dal gatto. Salutiamo Gennarino e la sua cortesia e paghiamo la notte (cifra irrisoria di € 5,00, comprensivo di utilizzo docce ed allaccio elettrico), ringraziandolo per l’ospitalità dimostrata. Ripartiamo, dopo carico/scarico, soltanto in tarda mattinata e ovviamente, prima di riprendere la marcia, ci fermiamo sotto il cartello del paese per una foto stupida. "Fardella", in dialetto marchigiano e non solo, è la “ciambella” che appare a chi è particolarmente in sovrappeso, quando si siede, o fuori dai vestiti. Avendo noi sempre problemi con il grasso superfluo, questo paese è estremamente azzeccato. Come perderci, dunque, l'occasione della foto con il nome del paese che più ci rappresenta?
La mattinata inizia presto come sempre. Dopo la colazione, mentre monitorniamo Mercurio al guinzaglio che sgamba nel prato ordinatissimo della nostra piccola area di sosta, ci intratteniamo in chiacchiere con una coppia di camperisti con bimbo al seguito, che attacca bottone affascinato dal gatto. Salutiamo Gennarino e la sua cortesia e paghiamo la notte (cifra irrisoria di € 5,00, comprensivo di utilizzo docce ed allaccio elettrico), ringraziandolo per l’ospitalità dimostrata. Ripartiamo, dopo carico/scarico, soltanto in tarda mattinata e ovviamente, prima di riprendere la marcia, ci fermiamo sotto il cartello del paese per una foto stupida. "Fardella", in dialetto marchigiano e non solo, è la “ciambella” che appare a chi è particolarmente in sovrappeso, quando si siede, o fuori dai vestiti. Avendo noi sempre problemi con il grasso superfluo, questo paese è estremamente azzeccato. Come perderci, dunque, l'occasione della foto con il nome del paese che più ci rappresenta? La strada verso Maratea è un continuo irto saliscendi, e per percorrere 80 chilometri, oltre a perderci un paio di volte perché il segnale gps impazzisce, ci mettiamo oltre due ore (esclusa la sosta da Acqua e Sapone per un paio di commissioni). In realtà, per agevolarci con la strada, prendiamo la litoranea da sud, e l’ultimo tratto per raggiungere la statua del Cristo Redentore si inerpica scoprendo un’acqua che si fa forte dei suoi colori nonostante il cielo non limpido. Per raggiungere il Cristo, però, c’è una strada eccessivamente tortuosa e piena di tornanti a gomito, pertanto decidiamo di tirare dritto, navigando a vista. Ci fermiamo nei pressi di San Nicola Arcella per pranzo vista mare con sabbia nera!
La strada verso Maratea è un continuo irto saliscendi, e per percorrere 80 chilometri, oltre a perderci un paio di volte perché il segnale gps impazzisce, ci mettiamo oltre due ore (esclusa la sosta da Acqua e Sapone per un paio di commissioni). In realtà, per agevolarci con la strada, prendiamo la litoranea da sud, e l’ultimo tratto per raggiungere la statua del Cristo Redentore si inerpica scoprendo un’acqua che si fa forte dei suoi colori nonostante il cielo non limpido. Per raggiungere il Cristo, però, c’è una strada eccessivamente tortuosa e piena di tornanti a gomito, pertanto decidiamo di tirare dritto, navigando a vista. Ci fermiamo nei pressi di San Nicola Arcella per pranzo vista mare con sabbia nera!Il caldo è indescrivibile ma non mi faccio mancare due passi lungo la ripida scalinata che porta al belvedere sull’Arcomagno e sul suo splendido mare turchese. Gli speroni rocciosi e le loro fessure dividono minuscole calette di sassi grigi e sabbiolina: qualcuno fa il bagno e qualcuno, seppur nuvoloso, se ne sta steso sul telo da mare a godersi gli ultimi raggi d’estate.


Tra l’altro, le calette di San Nicola Arcella sembrerebbero essere tra le più belle e selvagge della Calabria: direi che siamo stati fortunati, dunque!
Una ventina di chilometri più a sud, ci fermiamo un’oretta sul lungomare di Diamante, con le sue caratteristiche viuzze con prodotti tipici calabresi, peperoncini appesi ai balconi e soprattutto murales e disegni sui muri in ogni dove.
 I disegni non sono i classici dei writers alle stazioni, ma sono armonici, ispirati al mare e alla satira. Sono oltre 150 le opere d'arte dipinte sui muri del centro storico, realizzate a partire dal 1981 da pittori e artisti di fama internazionale. Matilde Serao e Gabriele D'Annunzio sono tra i tanti letterati che hanno rivolto la loro attenzione a quella che hanno definito "la perla del Tirreno". Nel complesso il borgo è grazioso, con un bel lungomare pavimentato con piastrelle che creano motivi geometrici, peccato per alcuni muri un po’ scrostati: l’aria salmastra è devastante per questi poveri paesetti appoggiati sulla spiaggia.
I disegni non sono i classici dei writers alle stazioni, ma sono armonici, ispirati al mare e alla satira. Sono oltre 150 le opere d'arte dipinte sui muri del centro storico, realizzate a partire dal 1981 da pittori e artisti di fama internazionale. Matilde Serao e Gabriele D'Annunzio sono tra i tanti letterati che hanno rivolto la loro attenzione a quella che hanno definito "la perla del Tirreno". Nel complesso il borgo è grazioso, con un bel lungomare pavimentato con piastrelle che creano motivi geometrici, peccato per alcuni muri un po’ scrostati: l’aria salmastra è devastante per questi poveri paesetti appoggiati sulla spiaggia. 
Si congeda, voltandosi un paio di volte ad augurarci buona serata e a ripeterci che, qualsiasi cosa ci serva, basta fare un fischio. Nell’area sosta non c’è nessuno, ma siamo tranquilli.
Peccato il caldo torrido che non ci dà tregua fino a tarda serata. I miei si schiaffano davanti al ventilatore, Mercurio boccheggia e lecca cubetti di ghiaccio.
Io mi rinfresco con una doccia.
Stanotte si dorme con le finestre aperte.
da Paola a Scilla (226 km)
Dopo una notte abbastanza calda, finalmente poco prima dell’alba l’aria inizia a rinfrescare. Ci svegliamo di buon’ora come sempre, e finalmente riusciamo a vedere l’area camper: non è enorme, c’è odore di fichi e di mare, un albero è praticamente dietro al nostro camper e a dieci metri c’è un minuscolo sottopasso che porta direttamente alla spiaggia rocciosa.

Le onde si infrangono potenti e lasciano una bruma sottile nella foschia del mattino, il cielo è velato ma la temperatura va aumentando. Io e Vergara ne approfittiamo per lavare i capelli ed utilizzare la piastra, mentre il babbo porta Mercurio a sgambare fuori. Dopo un rapido carico/scarico, ci intratteniamo qualche minuto in chiacchiere con Massimiliano, venuto a salutarci con un mazzetto di peperoncini pronti da utilizzare nella pasta o sulle bruschette. La cordialità di questa gente è impagabile, sono pieni di cuore e davvero disponibili. Alla fine, per la notte abbiamo speso € 15,00 (compresa elettricità, acqua ed utilizzo delle docce) e ne è valsa davvero la pena.
 Ci allontaniamo verso Tropea, mentre lasciamo recensioni positive al B&B. Rapido blitz da Lidl per il pane e, attraverso saliscendi e SS18, raggiungiamo Tropea all’ora di pranzo e ci fermiamo in un ampio parcheggio a ridosso della spiaggia. La meraviglia! Gli regaliamo felicemente 2,00 € l’ora, ma non importa: non vediamo l’ora di assaporare un po’ di “Calabria famosa” con un paio di raggi di sole che hanno pulito l’aria (benché sia molto caldo!) e restituiscono giustizia al mare e alle sue cento sfumature di azzurro.
Ci allontaniamo verso Tropea, mentre lasciamo recensioni positive al B&B. Rapido blitz da Lidl per il pane e, attraverso saliscendi e SS18, raggiungiamo Tropea all’ora di pranzo e ci fermiamo in un ampio parcheggio a ridosso della spiaggia. La meraviglia! Gli regaliamo felicemente 2,00 € l’ora, ma non importa: non vediamo l’ora di assaporare un po’ di “Calabria famosa” con un paio di raggi di sole che hanno pulito l’aria (benché sia molto caldo!) e restituiscono giustizia al mare e alle sue cento sfumature di azzurro. Inizio la visita da una caletta che mi fa togliere subito subito i sandali, e ciao alla sabbia tra le dita, che quando mi ricapita! Se ne sta nascosta dietro il crostone di roccia che si trova davanti a destra della spiaggia, lo stesso crostone su cui sorge il Santuario. C’è altra gente che tenta di fotografare le onde, mi butto anche io alla ricerca dello scatto migliore.
Inizio la visita da una caletta che mi fa togliere subito subito i sandali, e ciao alla sabbia tra le dita, che quando mi ricapita! Se ne sta nascosta dietro il crostone di roccia che si trova davanti a destra della spiaggia, lo stesso crostone su cui sorge il Santuario. C’è altra gente che tenta di fotografare le onde, mi butto anche io alla ricerca dello scatto migliore. La leggenda vuole che il fondatore di questa loca
lità sia stato Ercole quando, di ritorno dalle Colonne d'Ercole (attuale Gibilterra), si fermò sulle coste del Sud Italia. Nelle zone limitrofe sono state rinvenute tombe di origine magno-greca.


 È probabile che lo scoglio dell'isola fosse abitato, intorno al VII-VIII secolo, da eremiti. Questi, isolandosi dal mondo civile, si dedicavano ad una vita contemplativa e ascetica. Per molti anni appartenne ai monaci basiliani e a partire dall'XI Secolo vi abitarono i monaci Benedettini. In seguito ai terremoti del 1783 e del 1905, si conserva ben poco della struttura originaria. Ci fermiamo ad ammirarla dalla prima terrazzina lungo la scalinata che poi sale verso il centro storico, ma dal belvedere di Piazza del Cannone (dove si trova anche il fotografato “I LOVETROPEA”) c’è sicuramente la vista più panoramica sulla Rocca di Tropea.
È probabile che lo scoglio dell'isola fosse abitato, intorno al VII-VIII secolo, da eremiti. Questi, isolandosi dal mondo civile, si dedicavano ad una vita contemplativa e ascetica. Per molti anni appartenne ai monaci basiliani e a partire dall'XI Secolo vi abitarono i monaci Benedettini. In seguito ai terremoti del 1783 e del 1905, si conserva ben poco della struttura originaria. Ci fermiamo ad ammirarla dalla prima terrazzina lungo la scalinata che poi sale verso il centro storico, ma dal belvedere di Piazza del Cannone (dove si trova anche il fotografato “I LOVETROPEA”) c’è sicuramente la vista più panoramica sulla Rocca di Tropea.
E, per fortuna, il caldo è meno torrido di ieri!
da Scilla a Milazzo (72 km)
Stamattina, dopo una notte passata con il prurito di non so quali insetti di cui l’area camper è funestata (e abbiamo pure pagato gli stessi 15,00 € di Matera e di Massimiliano, con un quarto della qualità e della cortesia!), ci svegliamo di buon’ora. Mentre il babbo fa sgambare Mercurio, io e Vergara ci dedichiamo alla pulizia camper. Il tempo non promette nulla, pesanti nuvole coprono il cielo e la bruma fa il cappello alle montagne. Però, indubbiamente, l’area sosta con la luce del giorno ha una vista stupenda, un bellissimo panorama sul Tirreno e, finalmente, stamattina vediamo la costa della Sicilia!
Svuotiamo la cassetta wc e poi ritorniamo 4 km verso Scilla per un breve tour. Lungo la strada Nazionale appare un bel divieto di accesso ai camper, quindi ci fermiamo un attimo e scendo a chiedere al punto turistico (segnalato, ma rimediato in un hotel!) se ci sia un posto per parcheggiare un bestione un paio d’ore, forte anche del fatto che in bassa stagione siamo sempre agevolati. Il tipo alla reception, con marcato accento calabrese, mi fa un gesto come a dire di non preoccuparmi, e mi spiega: “Figurati, parcheggiate pure dove volete, siamo in bassa stagione!” si avvicina ed abbassa la voce “Questi cartelli li mettono per l’estate, perché c’è tanta gente... ma adesso chi ci viene!”
 Ringraziamo e parcheggiamo, dunque, in fondo al lungomare, dove sono ben visibili i segni della recente mareggiata che ha trasportato sabbia in mezzo alla strada. I chioschetti chiusi, i ristorantini che si svegliano tra i muri scrostati dalla salsedine, il legno arido delle persiane scolorite. Tutto crea un’atmosfera pittoresca.
Momento Quark: secondo la mitologia greca, Scilla era una ninfa marina che per gelosia fu trasformata da Circe in un mostro mentre faceva il bagno in una caletta presso Zancle (l’odierna Messina); al posto delle gambe ebbe sei teste di cane che latravano, e lunghe code di serpente. La storia è raccontata nell’Odissea di Omero e nella Metamorfosi di Ovidio.
Ringraziamo e parcheggiamo, dunque, in fondo al lungomare, dove sono ben visibili i segni della recente mareggiata che ha trasportato sabbia in mezzo alla strada. I chioschetti chiusi, i ristorantini che si svegliano tra i muri scrostati dalla salsedine, il legno arido delle persiane scolorite. Tutto crea un’atmosfera pittoresca.
Momento Quark: secondo la mitologia greca, Scilla era una ninfa marina che per gelosia fu trasformata da Circe in un mostro mentre faceva il bagno in una caletta presso Zancle (l’odierna Messina); al posto delle gambe ebbe sei teste di cane che latravano, e lunghe code di serpente. La storia è raccontata nell’Odissea di Omero e nella Metamorfosi di Ovidio.  Nell’antichità poi, si credeva che l’imboccatura settentrionale dello stretto di Messina (in corrispondenza del passaggio tra la penisoletta di Scilla in Calabria e il capo siciliano di Cariddi), fosse pericolosissima per la navigazione, arrivando addirittura a far derivare questi nomi da quelli di due mitologici spaventosi mostri divoratori di naviganti. Benché non ci sia mai stata una evidenza storica, il primo a parlarci di Scilla e Cariddi come di mitici mostri sanguinari fu Omero nella sua Odissea, Nacque pertanto più tardi il detto: “Incappa in Scilla volendo evitare Cariddi”, per significare ‘cadere dalla padella nella brace’.
Nell’antichità poi, si credeva che l’imboccatura settentrionale dello stretto di Messina (in corrispondenza del passaggio tra la penisoletta di Scilla in Calabria e il capo siciliano di Cariddi), fosse pericolosissima per la navigazione, arrivando addirittura a far derivare questi nomi da quelli di due mitologici spaventosi mostri divoratori di naviganti. Benché non ci sia mai stata una evidenza storica, il primo a parlarci di Scilla e Cariddi come di mitici mostri sanguinari fu Omero nella sua Odissea, Nacque pertanto più tardi il detto: “Incappa in Scilla volendo evitare Cariddi”, per significare ‘cadere dalla padella nella brace’.

 Vorrei attraversare la fortezza per arrivare al Faro di Scilla, ma preferisco buttarmi verso Chianalea, il cuore più antico del paese.
Vorrei attraversare la fortezza per arrivare al Faro di Scilla, ma preferisco buttarmi verso Chianalea, il cuore più antico del paese.  Le case di Chianalea sono costruite direttamente sugli scogli, e sono separate da viuzze strette che scendono fino al Mar Tirreno e che – viste dall’alto – sembrano un po’ i canali veneziani. Un’atmosfera magica, che le è valsa l’ingresso tra i Borghi più Belli d’Italia. Qui si respira l’aria dei borghi marinari più autentici, in giornate uggiose e ventose come questa respiro l’aria salmastra, mi arriva l’odore della salsedine e mi perdo tra le piante fuori dalle casette affacciate sulla via acciottolata e silenziosa, interrotta solo dalle onde che si infrangono contro gli scogli e dai pescatori che riparano le loro barchette azzurre. Mi ricorda il villaggio maltese di Marsaxlokk, questo angolo di Calabria. Mi ricorda alcuni scorci di cui ero solita innamorarmi quando vivevo lì in mezzo al Mediterraneo più profondo.
Le case di Chianalea sono costruite direttamente sugli scogli, e sono separate da viuzze strette che scendono fino al Mar Tirreno e che – viste dall’alto – sembrano un po’ i canali veneziani. Un’atmosfera magica, che le è valsa l’ingresso tra i Borghi più Belli d’Italia. Qui si respira l’aria dei borghi marinari più autentici, in giornate uggiose e ventose come questa respiro l’aria salmastra, mi arriva l’odore della salsedine e mi perdo tra le piante fuori dalle casette affacciate sulla via acciottolata e silenziosa, interrotta solo dalle onde che si infrangono contro gli scogli e dai pescatori che riparano le loro barchette azzurre. Mi ricorda il villaggio maltese di Marsaxlokk, questo angolo di Calabria. Mi ricorda alcuni scorci di cui ero solita innamorarmi quando vivevo lì in mezzo al Mediterraneo più profondo.
Martedì, 06 ottobre – km 108088
da Milazzo a Cefalù (164 km)
Stamattina ripartiamo in direzione Tindari ed il suo Santuario. Il cielo, seppur, nuvoloso, lascia intravedere qualche timido raggio di sole mentre costeggiamo il mare e ci infiliamo nelle viuzze che si avvitano lungo le rocce. Arriviamo con estrema calma verso le 9:45, riusciamo a parcheggiare sotto alla chiesa (elevata a Basilica Minore nel 2018 da Papa Francesco) e ci avviamo a piedi. Appena fuori dal parcheggio, conosciamo Nunziatina, con il suo piccolo negozietto di specialità artigianali siciliane, che non manca di offrirci uno sproposito di dolcetti di pasta di mandorle. Ci fa assaggiare frutta secca e bergamotto disidratato, troppo buoni per dire di no, quindi ci ripromettiamo di acquistare qualcosa al ritorno.


Riprendiamo la marcia verso Capo d’Orlando, dove ci fermiamo per il pranzo in un parcheggio vista mare di fronte ad un ristorante. Subito dopo, un breve tour al Laghetto di Capo d’Orlando (praticamente a 100 metri), minuscolo specchio d’acqua formatosi probabilmente in una depressione del terreno ed alimentato da falde acquifere sotterranee dolci e salate.


Poi raggiungo il belvedere del Monte della Madonna attraverso una scaletta che trovo nel parcheggio (a senso, mi rendo conto che può tornare utile come scorciatoia, l’unico inconveniente è passare dentro un boschetto di poche decine di metri). Salgo lungo una grossa scalinata in pietra che ripercorre le tappe della Via Crucis, e in cima trovo i ruderi del castello dei XII Secolo e il piccolo santuario, che dominano la città ed il golfo da cui, se fosse più limpido, si vedrebbero nitidamente le Eolie.


Decidiamo di restare qui e non cercare oltre... non fosse altro che per la fatica fatta per arrivarci!
Mercoledì 07 ottobre – km 108252
da Cefalù a Palermo (91 km)
Stamattina lasciamo 1,00 € l’ora al parcheggio della stazione (fino alle 12:15) ed andiamo in avanscoperta.
 Attraverso Corso Ruggero, a poche centinaia di metri, raggiungiamo la Cattedrale arabo-normanna di Cefalù e diamo un’occhiata all’interno: l’abside ospita uno dei tre mosaici del Cristo Pantocratore di tutta la Sicilia, di chiaro stampo bizantino. La struttura massiccia è tipica delle costruzioni del dominio arabo, che erano spesso edificate in stile fortezza militare.
Attraverso Corso Ruggero, a poche centinaia di metri, raggiungiamo la Cattedrale arabo-normanna di Cefalù e diamo un’occhiata all’interno: l’abside ospita uno dei tre mosaici del Cristo Pantocratore di tutta la Sicilia, di chiaro stampo bizantino. La struttura massiccia è tipica delle costruzioni del dominio arabo, che erano spesso edificate in stile fortezza militare. 

 Poco più avanti, il lavatoio medievale, un magnifico esempio di spaccato di vita medievale siciliana, nonché di ingegneria idraulica dell’epoca che mostra la semplice ma ingegnosa tecnica di convoglio delle acque reflue che, veicolate attraverso un piccolo antro, sfociano direttamente a mare. Si accede attraverso una scalinata in pietra lavica detta “a lumachella”. Questa porta ad uno spazio parzialmente coperto, in cui trovano posto una serie di piccole vasche in cui l’acqua del fiume Cefalino (convogliata, appunto) sgorga attraverso numerose bocche di ghisa. Il lavatoio fu demolito nel 1514 e ricostruito in una posizione più arretrata rispetto alle mura cittadine e successivamente intorno al 1600 fu anche coperta la parte del fiume che scorreva a cielo aperto. Una curiosa scritta posta sul lato destro dell’ingresso riporta il visitatore ad un’antica leggenda: “Qui scorre Cefalino, più salubre di qualunque altro fiume, più puro dell’argento, più freddo della neve”. La leggenda narra che Cefalino fu generato dalle lacrime incessanti di una ninfa pentita di aver punito con la morte, il tradimento del suo amato.
Poco più avanti, il lavatoio medievale, un magnifico esempio di spaccato di vita medievale siciliana, nonché di ingegneria idraulica dell’epoca che mostra la semplice ma ingegnosa tecnica di convoglio delle acque reflue che, veicolate attraverso un piccolo antro, sfociano direttamente a mare. Si accede attraverso una scalinata in pietra lavica detta “a lumachella”. Questa porta ad uno spazio parzialmente coperto, in cui trovano posto una serie di piccole vasche in cui l’acqua del fiume Cefalino (convogliata, appunto) sgorga attraverso numerose bocche di ghisa. Il lavatoio fu demolito nel 1514 e ricostruito in una posizione più arretrata rispetto alle mura cittadine e successivamente intorno al 1600 fu anche coperta la parte del fiume che scorreva a cielo aperto. Una curiosa scritta posta sul lato destro dell’ingresso riporta il visitatore ad un’antica leggenda: “Qui scorre Cefalino, più salubre di qualunque altro fiume, più puro dell’argento, più freddo della neve”. La leggenda narra che Cefalino fu generato dalle lacrime incessanti di una ninfa pentita di aver punito con la morte, il tradimento del suo amato.  Con le sue ripide stradine scolpite nella roccia, questa cittadina sembra teneramente aggrappata alle ultime pendici interne del monte San Calogero. Di significativa importanza è il Castello, una costruzione difensiva tra le più grandi e meglio conservate tra i castelli normanni in Sicilia e in Italia. Il sito in origine, per la particolare posizione strategica, era probabilmente occupato da una fortezza o torre d'avvistamento di matrice araba. Le strutture in stile normanno furono conferite dal signore di Caccamo, nel XII Secolo in seguito alla riconquista dell'isola.
Con le sue ripide stradine scolpite nella roccia, questa cittadina sembra teneramente aggrappata alle ultime pendici interne del monte San Calogero. Di significativa importanza è il Castello, una costruzione difensiva tra le più grandi e meglio conservate tra i castelli normanni in Sicilia e in Italia. Il sito in origine, per la particolare posizione strategica, era probabilmente occupato da una fortezza o torre d'avvistamento di matrice araba. Le strutture in stile normanno furono conferite dal signore di Caccamo, nel XII Secolo in seguito alla riconquista dell'isola. 

 L’ingresso costa 6,00 € a persona, la grossa scalinata in pietre che porta all’entrata è lunga (occhio alle calzature!) e dissestata, ma la bellissima vista della campagna circostante e dei tetti di questo borgo di ottomila anime ne vale decisamente la pena.
L’ingresso costa 6,00 € a persona, la grossa scalinata in pietre che porta all’entrata è lunga (occhio alle calzature!) e dissestata, ma la bellissima vista della campagna circostante e dei tetti di questo borgo di ottomila anime ne vale decisamente la pena.Dopo il castello, un blitz alla Chiesa Madre di San Giorgio Martire, che deve la sua dedicazione ai normanni posti sotto la protezione del santo guerriero a ricordo della vittoria sui Saraceni riportata nei pressi di Cerami nel 1090. Negli anni 1477 - 1480 la costruzione venne ingrandita ed arricchita di numerose opere d'arte, espressione del rinascimento siciliano, grazie alla munificenza ed al governo delle casate aragonesi. L’interno è maestoso e luminosissimo: l'impianto è a croce latina si articola in tre navate divise da colonne monolitiche in pietra locale che sorreggono arcate a tutto sesto. I dipinti delle volte e delle lunette laterali sono stati eseguiti solo secoli dopo (a metà del Secolo scorso per l’esattezza, ed è evidente lo stacco di stile), così come le decorazioni della volta e delle pareti in stile impero. Il pavimento della Chiesa lastricato con marmi grigi, neri e rosati di Carrara, è stato rifatto ed ha sostituito quello preesistente in mattonelle di maiolica. Nel complesso, molto bella.
Domattina la sveglia suonerà presto!
Giovedì 08 ottobre – km 108343
Palermo (circa 13 km a piedi!)
 Stamattina alle 8.30 siamo già colazionati e fuori dall’area camper, e dopo esserci persi imboccando una strada anziché un’altra, finalmente raggiungiamo Corso Calatafimi, che arriva fino a Porta Nuova, ufficialmente la porta di ingresso al centro storico della capitale siciliana. Adiacente al Palazzo dei Normanni, è statainfatti per secoli il più importante accesso a Palermo via terra. Perfezionata su più livelli, fu voluta nel 1583 dal viceré Marcantonio Colonna per celebrare la vittoria sulle armate turche e commemorare i trionfi del sovrano. Nonostante il Senato cittadino avesse imposto il nome di Porta Austriaca, il popolo palermitano continuò ad appellare il monumentale varco come Porta Nuova. E tale rimase!
Stamattina alle 8.30 siamo già colazionati e fuori dall’area camper, e dopo esserci persi imboccando una strada anziché un’altra, finalmente raggiungiamo Corso Calatafimi, che arriva fino a Porta Nuova, ufficialmente la porta di ingresso al centro storico della capitale siciliana. Adiacente al Palazzo dei Normanni, è statainfatti per secoli il più importante accesso a Palermo via terra. Perfezionata su più livelli, fu voluta nel 1583 dal viceré Marcantonio Colonna per celebrare la vittoria sulle armate turche e commemorare i trionfi del sovrano. Nonostante il Senato cittadino avesse imposto il nome di Porta Austriaca, il popolo palermitano continuò ad appellare il monumentale varco come Porta Nuova. E tale rimase! 



Buono a sapersi, insomma.
Lascio di nuovo il mio gruppo di “vecchietti” e vado rapida verso Piazza Villena (più nota come Quattro Canti), snodo cruciale nel centro storico di Palermo. L'architettura è molto semplice, rappresenta un perfetto ottagono formato da quattro edifici alternati da sbocchi viari. I famosi “Quattro Canti” sono le quattro facciate decorative che delimitano lo spazio dell'incrocio.




Torno indietro a Quattro Canti, e ritrovo per caso i miei e gli altri in Piazza Bellini, davanti alle chiese di San Cataldo e Santa Maria dell’Ammiraglio, conosciuta come “La Martorana”, che nasconde al suo interno un tesoro bizantino: l’armonica fusione di stili artistici che caratterizza le decorazioni della chiesa è una testimonianza delle diverse popolazioni che hanno vissuto e governato in Sicilia nel corso dei secoli.





Esco soddisfatta da questa chiesa (il cui ingresso costa solo 2,00 € e li vale tutti!) e proseguo il mio tour. Raggiungo la Chiesa di Sant’Anna (chiusa), passo rapidamente dentro il mercato di Vucciria, ma mi fa sentire a disagio il fatto che nelle viuzze attorno alla piazzetta centrale non ci sia quasi nessuno (in compenso, un forte odore di pescheria e frutta marcia).

 Tiro oltre fino al porto, c’è il sole ed una lieve brezza mi impedisce di sudare mentre passeggio oltre Porta Felice, lungo il Foro Italico Umberto I. Qui spicca un edificio color ocra con un bellissimo ritratto di due simboli che per la Sicilia hanno fatto tanto e l’hanno pagato con la vita: un murales gigante raffigura infatti Falcone e Borsellino in quell’immagine ormai famosissima, stampata nella mente di chiunque pensi a loro: forse una delle immagini più celebri della storia recente, scattata nel 1992 ai magistrati dal fotoreporter Tony Gentile, mentre sorridono e si parlano all’orecchio nel corso della presentazione della candidatura alla Camera dei deputati del loro collega Giuseppe Ayala.
Tiro oltre fino al porto, c’è il sole ed una lieve brezza mi impedisce di sudare mentre passeggio oltre Porta Felice, lungo il Foro Italico Umberto I. Qui spicca un edificio color ocra con un bellissimo ritratto di due simboli che per la Sicilia hanno fatto tanto e l’hanno pagato con la vita: un murales gigante raffigura infatti Falcone e Borsellino in quell’immagine ormai famosissima, stampata nella mente di chiunque pensi a loro: forse una delle immagini più celebri della storia recente, scattata nel 1992 ai magistrati dal fotoreporter Tony Gentile, mentre sorridono e si parlano all’orecchio nel corso della presentazione della candidatura alla Camera dei deputati del loro collega Giuseppe Ayala. Sono ai bordi del quartiere arabo di Kalsa, che poi è gran parte del centro di Palermo, ed incontro Porta Sant’Agata, edificata in periodo normanno, che prende il nome dalla limitrofa Chiesa di Sant'Agata la Pedata. Costituisce una delle più antiche testimonianze della cinta muraria medievale: a parte un recente restauro all’inizio degli anni Ottanta, non vi è traccia di modifiche o trasformazioni nel corso dei secoli. Insomma, mille anni e non sentirli.
Più avanti continuo su Via Torino e poi su Via Magione per una decina di minuti, ne approfitto per entrare nella Chiesa di Santa Maria dello Spasimo, l’incompiuta, utilizzata attualmente per spettacoli musicali (la navata centrale è infatti occupata da file di sedie e l’altare è adibito a piccolo palco).

“A Palermo nel cuore del centro c'è un'antica focacceria
Davanti alla Chiesa di San Francesco, si ritrovano sempre lì
Seduti al tavolo che fu di Sciascia a bere Heineken e caffè
Sono la banda del sogno interrotto di una Sicilia che non c'è”

In ogni caso, molto buoni: ho modo di verificarlo sotto la Chiesa di San Francesco Saverio, dove finalmente riesco a sedermi dopo ore che giro come una trottola. Peccato non aver calcolato bene le dimensioni del pranzo, e così mi ritrovo due arancine sullo stomaco fino a sera. Sperando di smaltire, mi sposto per raggiungere il Ponte dell’Ammiraglio, percorrendo un paio di chilometri, nell’unico momento in cui il sole è a picco senza una nuvola in cielo!
 Arrivo abbastanza in fretta, un po’ accaldata, ma il ponte meritava una visita: del resto è l’unico ponte nella “collezione” dei siti Unesco già citati precedentemente. Costruito nel 1130 circa, costituisce un’importante testimonianza dell’architettura civile di età normanna: è infatti uno dei massimi prodotti d’ingegneria medievale in area mediterranea, interamente costruito in pietra da taglio. Deve il suo nome al fondatore Giorgio di Antiochia, ammiraglio del regno al servizio del re Ruggero II dal 1125 e anche fondatore della chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio (la Martorana, visitata stamattina). Il ponte fu eretto fuori dalla cinta muraria della città normanna e in origine attraversava il fiume Oreto. Sul Ponte dell’Ammiraglio, il 27 maggio dell'anno 1860, nel corso della Spedizione dei Mille, le truppe garibaldine si scontrarono con le truppe borboniche, posizionate per opporsi all’ingresso del nemico in città.
Arrivo abbastanza in fretta, un po’ accaldata, ma il ponte meritava una visita: del resto è l’unico ponte nella “collezione” dei siti Unesco già citati precedentemente. Costruito nel 1130 circa, costituisce un’importante testimonianza dell’architettura civile di età normanna: è infatti uno dei massimi prodotti d’ingegneria medievale in area mediterranea, interamente costruito in pietra da taglio. Deve il suo nome al fondatore Giorgio di Antiochia, ammiraglio del regno al servizio del re Ruggero II dal 1125 e anche fondatore della chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio (la Martorana, visitata stamattina). Il ponte fu eretto fuori dalla cinta muraria della città normanna e in origine attraversava il fiume Oreto. Sul Ponte dell’Ammiraglio, il 27 maggio dell'anno 1860, nel corso della Spedizione dei Mille, le truppe garibaldine si scontrarono con le truppe borboniche, posizionate per opporsi all’ingresso del nemico in città. Le tre navate della pianta a croce latina sono sorrette da grosse colonne bianche e soffitto interamente affrescato, con stucchi agli angoli, molto luminosa. L'edificio, completato attorno alla seconda metà del Cinquecento, costituì un raro esempio di eleganza rinascimentale inserito in una cornice ancora medievale. Con l'avvento del gusto barocco e le più grandi esigenze di spazio da parte dell'Ordine religioso, si portò avanti un'ampia opera di rifacimento con l'intento di edificare la più bella e fastosa chiesa barocca in Sicilia. Per due secoli, fino a tutto il Settecento, una moltitudine di artisti lavorarono alle decorazioni marmoree all'interno. Nel 1892 la chiesa del Gesù è stata dichiarata monumento nazionale. I devastanti bombardamenti del maggio 1943 danneggiarono pesantemente l’edificio, una bomba distrusse la cupola che cadendo trascinò con sé le parti vicine compreso gran parte delle opere che decoravano presbiterio e transetto. Per l’ennesima volta (era stata rifatta già altre tre volte), la cupola fu interamente ricostruita e un accurato restauro riuscì a recuperare i gravi sfregi inferti al monumento. Il 24 febbraio del 2009 dopo sei anni di impegnativi restauri, questo meraviglioso esempio del barocco palermitano è stato restituito alla città in tutto il suo splendore.
Le tre navate della pianta a croce latina sono sorrette da grosse colonne bianche e soffitto interamente affrescato, con stucchi agli angoli, molto luminosa. L'edificio, completato attorno alla seconda metà del Cinquecento, costituì un raro esempio di eleganza rinascimentale inserito in una cornice ancora medievale. Con l'avvento del gusto barocco e le più grandi esigenze di spazio da parte dell'Ordine religioso, si portò avanti un'ampia opera di rifacimento con l'intento di edificare la più bella e fastosa chiesa barocca in Sicilia. Per due secoli, fino a tutto il Settecento, una moltitudine di artisti lavorarono alle decorazioni marmoree all'interno. Nel 1892 la chiesa del Gesù è stata dichiarata monumento nazionale. I devastanti bombardamenti del maggio 1943 danneggiarono pesantemente l’edificio, una bomba distrusse la cupola che cadendo trascinò con sé le parti vicine compreso gran parte delle opere che decoravano presbiterio e transetto. Per l’ennesima volta (era stata rifatta già altre tre volte), la cupola fu interamente ricostruita e un accurato restauro riuscì a recuperare i gravi sfregi inferti al monumento. Il 24 febbraio del 2009 dopo sei anni di impegnativi restauri, questo meraviglioso esempio del barocco palermitano è stato restituito alla città in tutto il suo splendore. Ultima tappa della giornata, dopo aver incontrato di nuovo i miei davanti alla Cattedrale di Palermo ed essere salita sul camminamento delle torri (5,00 € per la salita, ma non è un granché. Decisamente più bella da sotto!) è la graziosa Chiesa di San Giovanni degli Eremiti, di chiaro stampo arabo, con le inconfondibili tre cupolette rosse. Sorge appena sotto le mura del Palazzo Reale.
Ultima tappa della giornata, dopo aver incontrato di nuovo i miei davanti alla Cattedrale di Palermo ed essere salita sul camminamento delle torri (5,00 € per la salita, ma non è un granché. Decisamente più bella da sotto!) è la graziosa Chiesa di San Giovanni degli Eremiti, di chiaro stampo arabo, con le inconfondibili tre cupolette rosse. Sorge appena sotto le mura del Palazzo Reale.E' uno dei più insigni edifici medievali di Palermo e uno dei monumenti-simbolo della città, costruito in epoca normanna sotto il regno di Ruggero II, ma radicalmente restaurata a fine Ottocento. Presenta una pianta a croce e una volumetria compatta e regolare, quasi cubica, e comprende anche un bellissimo chiostro a pianta quadrata, costituito da una sequenza continua di arcate a volta che poggiano su colonnine doppie.

 Queste caratteristiche stilistiche datano la sua costruzione probabilmente un paio di Secoli dopo la chiesa. Grazioso anche il giardino, con piante tropicali.
Queste caratteristiche stilistiche datano la sua costruzione probabilmente un paio di Secoli dopo la chiesa. Grazioso anche il giardino, con piante tropicali.
Rientro al camper poco dopo i miei, con un discreto mal di piedi (le ballerine non sono state proprio la scelta più azzeccata per pestare l’asfalto su e giù tutto il giorno!), ma una grossa soddisfazione per aver strizzato tutto ciò che volevo vedere in una giornata.
Venerdì 09 ottobre – km 108343
da Palermo a Terrasini (46 km)
La visita a Palermo prosegue con l’ultimo tassello: il Palazzo Reale (meglio noto come Palazzo dei Normanni) e la Cappella Palatina . Entro le 9 siamo già alla biglietteria (tralasciando che il gatto mi ha svegliata prima delle 5 e mi porterò dietro il mal di testa per tutto il giorno). Lo “sconto vecchietti” (over 65) porta ad un risparmio di ben 3,50 € sul totale del biglietto, che io pago ovviamente per intero (18,00 €).


Attualmente sede dell’Assemblea Regionale Siciliana, questa monumentale residenza è la più visitata di tutta la Sicilia ed iscritta nella solita lista di patrimoni Unesco “Palermo arabo-normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale”.
 L'attuale palazzo ingloba nelle fondamenta stratificazioni dei primi insediamenti fortificati di origine fenicio - punica databili fra l'VIII e il V secolo a.C. Qualche secolo più avanti, i Bizantini conquistarono la Sicilia e si impossessarono della fortificazione. La prima costruzione con funzioni di residenza reale denominata 'al Qasr o Kasr (Alcassar, la dimora degli emiri), è attribuita al periodo della dominazione islamica, lasso di tempo di circa due secoli ed oggetto di conquista da parte delle armate normanne, che nell'assedio di Palermo piantarono nelle immediate adiacenze il loro campo base. prima di sferrare gli attacchi alla Kalsa e al Cassaro fortificato. Nel 1132 Ruggero II di Sicilia costruì la parte mediana del palazzo, l'ampissimo appartamento che oggi prende il suo nome, e la Cappella Palatina.
L'attuale palazzo ingloba nelle fondamenta stratificazioni dei primi insediamenti fortificati di origine fenicio - punica databili fra l'VIII e il V secolo a.C. Qualche secolo più avanti, i Bizantini conquistarono la Sicilia e si impossessarono della fortificazione. La prima costruzione con funzioni di residenza reale denominata 'al Qasr o Kasr (Alcassar, la dimora degli emiri), è attribuita al periodo della dominazione islamica, lasso di tempo di circa due secoli ed oggetto di conquista da parte delle armate normanne, che nell'assedio di Palermo piantarono nelle immediate adiacenze il loro campo base. prima di sferrare gli attacchi alla Kalsa e al Cassaro fortificato. Nel 1132 Ruggero II di Sicilia costruì la parte mediana del palazzo, l'ampissimo appartamento che oggi prende il suo nome, e la Cappella Palatina. Dal Cortile Maqueda (l’elegante e sobrio loggiato su tre livelli) si accede a tutte le zone. Sicuramente la parte più interessante è la Cappella Palatina, un tripudio di mosaici bizantini, tra i più importanti della Sicilia, raffiguranti il Cristo Pantocratore, gli evangelisti e scene bibliche varie.
A fianco della Cappella Palatina, in ordine di bellezza, possiamo mettere la Sala di Ruggero II, anche qui esplosioni d’oro in un ambiente però più raccolto. I temi delle decorazioini sono frivoli e mondani: sulle pareti si presentano creature reali e mitologiche, come pavoni e leoni, ma anche centauri. Scene di caccia al cervo tra alberi e palme, gironi di forme ornate che racchiudono disegni di animali e di piante, e la parte superiore della volta è rappresentata l’aquila che artiglia il coniglio (allegoria del contrasto coraggio-codardia). Nella fusione di culture e civiltà diverse che caratterizzò il regno normanno, certamente anche in questo caso sono evidenti le influenze arabe.
Dal Cortile Maqueda (l’elegante e sobrio loggiato su tre livelli) si accede a tutte le zone. Sicuramente la parte più interessante è la Cappella Palatina, un tripudio di mosaici bizantini, tra i più importanti della Sicilia, raffiguranti il Cristo Pantocratore, gli evangelisti e scene bibliche varie.
A fianco della Cappella Palatina, in ordine di bellezza, possiamo mettere la Sala di Ruggero II, anche qui esplosioni d’oro in un ambiente però più raccolto. I temi delle decorazioini sono frivoli e mondani: sulle pareti si presentano creature reali e mitologiche, come pavoni e leoni, ma anche centauri. Scene di caccia al cervo tra alberi e palme, gironi di forme ornate che racchiudono disegni di animali e di piante, e la parte superiore della volta è rappresentata l’aquila che artiglia il coniglio (allegoria del contrasto coraggio-codardia). Nella fusione di culture e civiltà diverse che caratterizzò il regno normanno, certamente anche in questo caso sono evidenti le influenze arabe. Non vale, secondo noi, il costo elevato del biglietto.
Usciti dal Palazzo dei Normanni, optiamo per la comoda soluzione autobus che in mezz’oretta ci porta a Monreale. Il n.389 passa a Via Indipendenza, praticamente di fronte alla residenza reale. Alle 11.20 siamo in bus, e prima di mezzogiorno siamo già in Piazza Vittorio Emanuele, davanti ai giardini e alla fontana ma, soprattutto, davanti alla facciata laterale del Duomo. Detto anche Basilica Cattedrale di Santa Maria la Nuova, fu costruito nel XII Secolo da Guglielmo II sui fianchi scoscesi del Monte Caputo a dominare tutta la Conca d’Oro. Guglielmo II è passato alla storia con il soprannome “il Buono”.

Questa fama fu costituita dalla meravigliosa costruzione architettonica del Duomo di Monreale, che porta con sé una leggenda. Pare che re Guglielmo II fosse devotissimo alla Madonna e che ella gli volle fare un miracolo. Infatti un giorno mentre era a caccia a Monreale, stanco dalle fatiche si addormentò sotto un albero di carrubo. Nel sonno gli apparve la Madonna che gli disse: “Nello stesso posto dove stai dormendo c’è nascosto un grande tesoro: scava e quando lo trovi costruisci in questo stesso luogo un tempio“; detto questo la Madonna scomparve. Il re, svegliatosi ed impressionato dal sogno, chiamò i suoi uomini e ordinò di sradicare il carrubo. Fatta una buca profonda apparve veramente il tesoro, tanto che il re stesso rimase sbalordito. Fece perciò chiamare i migliori architetti, i più esperti muratori e i più bravi mosaicisti (“i mastri di l’oru”) e subito si diede inizio ai lavori realizzando così una meraviglia architettonica: il Duomo di Monreale. I Siciliani furono entusiasti dell’eccezionale bellezza del Duomo di Monreale, tanto da promuovere ad “imperatore” il buon re Guglielmo.
Ora, la Cattedrale riaprirà alle 14.15, quindi giusto qualche foto e con un briefing di ricognizione decidiamo di fermarci per pranzo in un ristorantino lì in piazza. Involtini di melanzane, due chiacchiere e spaghetti alla Norma, decisamente buoni per essere una cosetta da menù turistico.
Dopo pranzo, con calma, arriviamo alla biglietteria. Il nostro tour parte dal chiostro (il biglietto d’ingresso costa 6,00 €), molto particolare.


 Addirittura, Guy de Maupassant scrisse:
Addirittura, Guy de Maupassant scrisse: “Il meraviglioso Chiostro di Monreale suggerisce alla mente una tale sensazione di grazia che ci si vorrebbe restare quasi per sempre… e chi non l’ha visto non può immaginare cosa sia l’armonia di un colonnato... meravigliano lo sguardo, e poi lo affascinano, lo incantano, vi generano quella gioia artistica che le cose d’un gusto assoluto fanno penetrare nell’anima attraverso gli occhi.”

 E scusate se è poco. In effetti, il chiostro (che faceva parte dell’antico convento benedettino) è un esempio stupendo di architettura bizantina realizzato sul finire del XII Secolo, e a tutt’oggi è il più completo monumento di scultura romanica in Sicilia.
E scusate se è poco. In effetti, il chiostro (che faceva parte dell’antico convento benedettino) è un esempio stupendo di architettura bizantina realizzato sul finire del XII Secolo, e a tutt’oggi è il più completo monumento di scultura romanica in Sicilia.Ricorda molto l’Alhambra di Granada, nonostante sia una costruzione prettamente romanica. Nell’angolo sud-ovest c’è “un chiostro nel chiostro” (il Chiostrino), anch’esso a pianta quadrata con gli stessi archi a sesto acuto che si trovano tutti attorno al chiostro principale. Al centro, la Fontana del Re con la sua vasca rotonda dalla quale si innalza una colonna riccamente intagliata a forma di fusto di palma stilizzato.
 Gli archi sono tutti sostenuti da capitelli appoggiati su elegantissime coppie di colonnine di marmo, affusolate e decorate alterne (lisce, con intarsi a mosaico, intagliate ad arabeschi) le cui basi raffigurano zampe di leone, foglie stilizzate, teste di animali, gruppi di uomini.
Gli archi sono tutti sostenuti da capitelli appoggiati su elegantissime coppie di colonnine di marmo, affusolate e decorate alterne (lisce, con intarsi a mosaico, intagliate ad arabeschi) le cui basi raffigurano zampe di leone, foglie stilizzate, teste di animali, gruppi di uomini. 
 In un momento storico in cui i libri venivano copiati a mano e quindi solo poche persone potevano possedere una Bibbia o parte di essa, soprattutto tenendo presente che la stragrande maggioranza dei cittadini era analfabeta, il mosaico (come la pittura e la scultura) costituiva la “Biblia pauperum” cioè la Bibbia dei poveri, perché serviva a mostrare visivamente a tutti ciò che il sacerdote predicava e insegnava.
Così i fedeli potevano fare memoria della storia della salvezza più facilmente. Riprendiamo il bus alle 15.40 ed arriviamo all’area sosta camper poco dopo le 16 (il bus ci ferma direttamente davanti all’incrocio con Via Quarto dei Mille, a 200 metri dalla base). Carico e scarico in tempo record, salutiamo cordialmente e ripartiamo.
In un momento storico in cui i libri venivano copiati a mano e quindi solo poche persone potevano possedere una Bibbia o parte di essa, soprattutto tenendo presente che la stragrande maggioranza dei cittadini era analfabeta, il mosaico (come la pittura e la scultura) costituiva la “Biblia pauperum” cioè la Bibbia dei poveri, perché serviva a mostrare visivamente a tutti ciò che il sacerdote predicava e insegnava.
Così i fedeli potevano fare memoria della storia della salvezza più facilmente. Riprendiamo il bus alle 15.40 ed arriviamo all’area sosta camper poco dopo le 16 (il bus ci ferma direttamente davanti all’incrocio con Via Quarto dei Mille, a 200 metri dalla base). Carico e scarico in tempo record, salutiamo cordialmente e ripartiamo.  La strada fuori Palermo scorre rapida, usciamo dalla A29 in direzione Terrasini e troviamo un parcheggio vista mare in zona Calarossa (tra l’altro siamo in pole position per il tramonto!) con un bar poco distante. Stasera, mentre scende il buio, il rumore del mare e l’arietta fresca ci cullano, ma domattina la colazione con granita non ce la toglie nessuno!
La strada fuori Palermo scorre rapida, usciamo dalla A29 in direzione Terrasini e troviamo un parcheggio vista mare in zona Calarossa (tra l’altro siamo in pole position per il tramonto!) con un bar poco distante. Stasera, mentre scende il buio, il rumore del mare e l’arietta fresca ci cullano, ma domattina la colazione con granita non ce la toglie nessuno! Sabato 10 ottobre – km 108309
da Terrasini a Segesta (208 km)
Dopo una nottata un po’ insonne, la mattina inizia comunque presto. Faccio due passi lungo la costa, poi dopo la prima delle dieci sgambate giornaliere di Mercurio, facciamo un blitz all’Eurospin e ripartiamo. Tralasciamo il navigatore che ci porta a fratte lungo una stradina che definire aberrante è poco: stretta, sconnessa ma soprattutto piena di rifiuti, praticamente una discarica a cielo aperto. Giù per il dirupo c’è pure una macchina che avrà 40 anni “sospesa” su una roccia, senza ruote ed arrugginita. Con estremo rammarico, ci tocca ammettere che la Sicilia profonda si svela ai nostri occhi come la Grecia, che fuori dalle zone turistiche è purtroppo sporca e abbandonata a se stessa.

Pochi chilometri dopo, arriviamo alla piccola “Barcellona palermitana”. Si tratta di Borgo Parrini, minuscola contrada di 20 abitanti che attira turisti e curiosi provenienti da ogni parte della Sicilia, e non solo. Negli ultimi anni è stata sapientemente ristrutturata e rivalorizzata dai residenti, secondo uno stile artistico che ricorda Gaudì: per me, che adoro Gaudì e Barcellona, questo angolino è amore a prima vista! La storia di questo borgo inizia nel Cinquecento con l’ordine dei Gesuiti di Palermo, che acquistarono alcuni terreni agricoli nella zona di Partinico (proprio da qui nasce il nome “Parrini” che significa appunto preti) e si stabilirono qui costruendo inoltre alcune strutture, comprese abitazioni per coloni e braccianti ed una chiesetta.



 Dopo la soppressione dell’Ordine dei Gesuiti nel 1767, la proprietà del borgo passò in mano al principe francese Henri d’Orleans, che ne volle sfruttare i fertili terreni per la produzione di vino. A partire dal secondo dopoguerra, come migliaia di altre frazioni italiane, la popolazione iniziò ad abbandonare il posto, per trasferirsi nelle grandi città, di conseguenza molti edifici rimasero a lungo disabitati per decenni. Negli ultimi anni, grazie all’intuizione di un imprenditore e dei pochi residenti, il borgo ha conosciuto una nuova vita. Alcune vecchie case sono state restaurate con uno stile che ricorda molto il modernismo catalano di Antoni Gaudì, con forme particolari, decorazioni con mosaici in ceramica e colori sgargianti. Anche pavimentazioni e muretti sono stati ricostruiti secondo il nuovo stile, che attira così tanti visitatori in questa piccola Barcellona Palermitana.
Dopo la soppressione dell’Ordine dei Gesuiti nel 1767, la proprietà del borgo passò in mano al principe francese Henri d’Orleans, che ne volle sfruttare i fertili terreni per la produzione di vino. A partire dal secondo dopoguerra, come migliaia di altre frazioni italiane, la popolazione iniziò ad abbandonare il posto, per trasferirsi nelle grandi città, di conseguenza molti edifici rimasero a lungo disabitati per decenni. Negli ultimi anni, grazie all’intuizione di un imprenditore e dei pochi residenti, il borgo ha conosciuto una nuova vita. Alcune vecchie case sono state restaurate con uno stile che ricorda molto il modernismo catalano di Antoni Gaudì, con forme particolari, decorazioni con mosaici in ceramica e colori sgargianti. Anche pavimentazioni e muretti sono stati ricostruiti secondo il nuovo stile, che attira così tanti visitatori in questa piccola Barcellona Palermitana.





Ammetto che, essendo sensibile all’argomento terremoto, mi viene il magone mentre cammino nelle vie, accanto a questi blocchi di detriti e cemento compattati, pensando alle vite strappate. Ciò che questo architetto ha fatto è stato riportare in vita una città, e restituirla alla memoria con un profondo atto d’amore, un omaggio “monumentale” a chi a Gibellina viveva: Burri ricopre le rovine della cittadina siciliana con una sorta di grande sudario in cemento, sulla mappa della vecchia città. I vicoli bianchi che oggi percorriamo, simili a delle profonde ferite del terreno, sono gli stessi del centro storico del paese prima del terremoto.
Ripartiamo con una deviazione dalla SP119 (su cui sembra presente un’interruzione della viabilità)... e ci ritroviamo lungo una mulattiera sterrata in mezzo alla campagna, così campagna che nell’ordine incontriamo:
- viti a perdita d’occhio
- un gregge di pecore
- un trattore
- calanchi sulla carreggiata
Il percorso sembra più un rally che una semplice trasferta, ma alla fine riusciamo a raggiungere la meta! Arriviamo nella zona del sito archeologico di Segesta, optiamo per il parcheggio poco distante dalla biglietteria e decidiamo il da farsi. Peccato che il sito sia già chiuso per orario invernale (dalle nostre fonti, risultava aperto fino alle 19:30, mentre invece chiude alle 17:30), quindi ci perdiamo in chiacchiere con vista Tempio (la parte principale dell’intera area archeologica visibile dal parcheggio!) e decidiamo di riprendere la marcia domani. Dopo cena, il buio ci regala una buona stellata con inclusa una bozza di via lattea e, ovviamente, il Tempio di Segesta illuminato.

da Segesta a Erice (128 km)
 Stamattina perdiamo un po’ di tempo pianificando un itinerario che includa calette e panorami sul mare, e soprattutto passiamo da Calatafimi all’area sosta camper comunale per carico/scarico gratuito. Alle 11:00, dopo 35 km di stradine e una breve sosta al Belvedere di Castellammare del Golfo, riusciamo a raggiungere Scopello, baluardo sud della Riserva Naturale dello Zingaro. Io mi fermo lungo la strada per un po’ di foto panoramiche alla Tonnara (peccato che non sia visitabile) e ai faraglioni, cercando poi di raggiungere una caletta ahimé inaccessibile.
Stamattina perdiamo un po’ di tempo pianificando un itinerario che includa calette e panorami sul mare, e soprattutto passiamo da Calatafimi all’area sosta camper comunale per carico/scarico gratuito. Alle 11:00, dopo 35 km di stradine e una breve sosta al Belvedere di Castellammare del Golfo, riusciamo a raggiungere Scopello, baluardo sud della Riserva Naturale dello Zingaro. Io mi fermo lungo la strada per un po’ di foto panoramiche alla Tonnara (peccato che non sia visitabile) e ai faraglioni, cercando poi di raggiungere una caletta ahimé inaccessibile.

Ammetto che il colore del mare in questo punto è davvero trasparente, c’è gente in spiaggia e anche a fare il bagno mentre io cammino con il sole in faccia e l’arietta che mi rinfresca. Attraverso tutta la baia e finalmente, all’altro lato, la foto d’insieme all’acqua e al promontorio (“lo capo”) che dà il nome a questa rinomata località turistica.

 Proseguo oltre il porticciolo fino al Faro di Capo San Vito, dove attendo i miei che arriveranno in camper a recuperarmi poco dopo (dal parcheggio fino al faro sono circa 2,5 km). La cosa più bella è la colonia felina che popola il faro: sono almeno una ventina di gatti, docili ed amichevoli che si lasciano accarezzare e fanno le fusa in modo disinteressato (sono già provvisti di crocchette e acqua, probabilmente qualcuno li nutre perché sembrano ben in salute). Mi sono innamorata, vorrei farne un mazzetto e portarli tutti a casa! I miei e gli altri arrivano poco dopo con i loro mezzi e mi trovano sommersa da gatti e zampette sui pantaloni. Pioviggina appena, ci spostiamo più a sud verso la Scogliera di Macari, che ha anche un’ampia zona di parcheggio per camper. Ci fermiamo per un po’ di foto, c’è una grottina che lascia passare l’acqua direttamente dal mare aperto, che tra l‘altro ha un bellissimo colore. La costa frastagliata è striata di rosso e bianco, le onde vi si infrangono contro, vento è fresco e piacevole.
Proseguo oltre il porticciolo fino al Faro di Capo San Vito, dove attendo i miei che arriveranno in camper a recuperarmi poco dopo (dal parcheggio fino al faro sono circa 2,5 km). La cosa più bella è la colonia felina che popola il faro: sono almeno una ventina di gatti, docili ed amichevoli che si lasciano accarezzare e fanno le fusa in modo disinteressato (sono già provvisti di crocchette e acqua, probabilmente qualcuno li nutre perché sembrano ben in salute). Mi sono innamorata, vorrei farne un mazzetto e portarli tutti a casa! I miei e gli altri arrivano poco dopo con i loro mezzi e mi trovano sommersa da gatti e zampette sui pantaloni. Pioviggina appena, ci spostiamo più a sud verso la Scogliera di Macari, che ha anche un’ampia zona di parcheggio per camper. Ci fermiamo per un po’ di foto, c’è una grottina che lascia passare l’acqua direttamente dal mare aperto, che tra l‘altro ha un bellissimo colore. La costa frastagliata è striata di rosso e bianco, le onde vi si infrangono contro, vento è fresco e piacevole.


La nostra ultima tappa è la Grotta Mangiapane, un antico insediamento preistorico e un geosito speleologico, che raggiungiamo attraverso una stradina quasi totalmente asfaltata ma molto stretta nell’ultimo chilometro. Un tratto sterrato porta invece proprio al parcheggio a fianco all’ingresso.



 Scavi archeologici condotti nel 2004 hanno poi rivelato la presenza di ceramica preistorica del Neolitico antico e medio, pertanto sembrerebbe che la grotta fosse stata abitata molto tempo prima del secolo scorso! Dopo oltre 30 anni di inutilizzo e disabitazione, dal 1982 è stata riportata in vita con una manifestazione natalizia denominata "Presepe vivente di Custonaci - La Natività e i Mestieri Tradizionali".
Scavi archeologici condotti nel 2004 hanno poi rivelato la presenza di ceramica preistorica del Neolitico antico e medio, pertanto sembrerebbe che la grotta fosse stata abitata molto tempo prima del secolo scorso! Dopo oltre 30 anni di inutilizzo e disabitazione, dal 1982 è stata riportata in vita con una manifestazione natalizia denominata "Presepe vivente di Custonaci - La Natività e i Mestieri Tradizionali".Si tratta, appunto, di un presepe vivente in cui rivivono le tradizioni contadine e artigianali di quel territorio, e che coinvolge tutti gli abitanti del paese, creando peraltro un'atmosfera decisamente suggestiva. Davvero molto particolare ed originale, tra l’altro la golden hour rende magnificamente dorate le rocce e le casette in pietra, ognuna dedicata ad un mestiere (dal fabbro al barbiere, dall’impagliatore di sedie al bottaio, dal decoratore di carretti siciliani, al “puparo”), mentre diversi animali razzolano allegri nell’ara.



Curiosità: nella grotta è stato girato l'episodio "Il ladro di merendine" della serie televisiva Il commissario Montalbano... anche se, ad essere sinceri, qualsiasi luogo siciliano è stato preso come riferimento cinematografico per la fortunata serie con Luca Zingaretti (non potrebbe essere altrimenti!). Altro dettaglio non trascurabile: il sito è ad offerta libera, perciò si prevede un contributo all’uscita. Non siamo spilorci: per quanto piccolino sia, è molto ben curato ed interessante, quindi qualche euro a testa li vale tutti. Meglio questo dei 5,00 € del parcheggio di stamattina a Scopello!
Tira vento, quindi meglio non alzare la parabola della tv.
Internet non prende quasi per niente.
Mai una gioia.
Lunedì 12 ottobre – km 108645
da Erice a Marsala (43 km)
La mattinata è molto fredda, perciò inauguro la felpona per un tour mattutino di Erice.


 Una delle icone di Erice è però il suo baluardo difensivo, ossia il Castello di Venere, arroccato sullo strapiombo che delimita il paese e risalente all’epoca normanna. Fu costruito tra il XII e XIII Secolo, sui resti di un primitivo tempio dedicato al culto della dea Venere. La sua fortunata posizione gli permetteva di scorgere in anticipo ogni attacco nemico proveniente da terra o dal mare, offrendo alla città un notevole vantaggio strategico.
Una delle icone di Erice è però il suo baluardo difensivo, ossia il Castello di Venere, arroccato sullo strapiombo che delimita il paese e risalente all’epoca normanna. Fu costruito tra il XII e XIII Secolo, sui resti di un primitivo tempio dedicato al culto della dea Venere. La sua fortunata posizione gli permetteva di scorgere in anticipo ogni attacco nemico proveniente da terra o dal mare, offrendo alla città un notevole vantaggio strategico. 

 Nulla può nascondersi alla vista dalle mura del castello, né la pianura di Trapani né le coste che ospitano Tonnara di Bonagia a nord e Marsala più a sud. In sede di costruzione, fu aggiunta anche la camminata e la scalinata in pietra che dal Castello di Venere porta alle Due Torri (la parte moderna adesso sede di un resort). Subito sotto lo sperone roccioso, arroccata su un cocuzzolo nascosto da una fitta vegetazione, svetta la graziosissima Torretta Pepoli, una residenza in stile moresco con richiami liberty, fatta costruire nel 1870 dal conte Pepoli per divenire un pacifico e panoramico ritrovo di uomini di cultura.
Nulla può nascondersi alla vista dalle mura del castello, né la pianura di Trapani né le coste che ospitano Tonnara di Bonagia a nord e Marsala più a sud. In sede di costruzione, fu aggiunta anche la camminata e la scalinata in pietra che dal Castello di Venere porta alle Due Torri (la parte moderna adesso sede di un resort). Subito sotto lo sperone roccioso, arroccata su un cocuzzolo nascosto da una fitta vegetazione, svetta la graziosissima Torretta Pepoli, una residenza in stile moresco con richiami liberty, fatta costruire nel 1870 dal conte Pepoli per divenire un pacifico e panoramico ritrovo di uomini di cultura.







 Raggiungo poi la Spiaggetta di Tramontana sul peduncolo su cui sorge il centro storico, subito prima del Bastione Conca, adornato da palme. Le prime fortificazioni della città verso il mare dal lato di tramontana vennero costruite alla fine del XIV Secolo dagli Aragonesi e corredate originariamente da quattro torri angolari in legno. Nel corso del '500 le difese vennero rafforzate e si eressero le mura e il Bastione Conca, in massiccia muratura. Questo, assieme al Bastione Imperiale, non assolse solo a funzioni difensive, ma sotto ad esso furono realizzate grandi cisterne per la raccolta dell'acqua dolce, già allora scarsa.
Sulla riva, il muro di cinta bianco protegge le casette dai tenui colori, tutte in fila come soldatini.
Raggiungo poi la Spiaggetta di Tramontana sul peduncolo su cui sorge il centro storico, subito prima del Bastione Conca, adornato da palme. Le prime fortificazioni della città verso il mare dal lato di tramontana vennero costruite alla fine del XIV Secolo dagli Aragonesi e corredate originariamente da quattro torri angolari in legno. Nel corso del '500 le difese vennero rafforzate e si eressero le mura e il Bastione Conca, in massiccia muratura. Questo, assieme al Bastione Imperiale, non assolse solo a funzioni difensive, ma sotto ad esso furono realizzate grandi cisterne per la raccolta dell'acqua dolce, già allora scarsa.
Sulla riva, il muro di cinta bianco protegge le casette dai tenui colori, tutte in fila come soldatini. 



Poco più avanti ci fermiamo al Museo del Sale delle Saline di Nubia , i miei si lanciano nella visita guidata ed io resto a fare foto ai dintorni. Ripartiamo con il sole già basso sull’orizzonte, pochi chilometri ancora ed arriviamo a Marsala, davanti alle saline omonime, nell’area di parcheggio di “Oro Bianco”, un piccolo bar/bazar a bordo strada. SI avvicina quello che probabilmente è il titolare: “Dovete pernottare?” ci chiede, con marcato accento trapanese. Rispondiamo di sì, toglie la catenella all’ingresso e ci lascia entrare. L’area di parcheggio è gratuita, ci aiuta con la manovra e ci chiede che tipo di ripieno vogliamo nei cornetti domani mattina per la colazione. A questo punto pensiamo che la colazione ci costerà venti euro! Prima di cena e dopo cena, sgambatina con Mercurio fuori, al freddo e al vento, finché la pioggia non ci costringe a rientrare.
da Marsala a Selinunte (90 km)
 Stamattina, come da programma, ore 8:30 tutti al barettino “Oro Bianco” per la colazione con brioche alla crema di pistacchio e granita al limone (con supplemento di classica brioscina da inzuppare).
Stamattina, come da programma, ore 8:30 tutti al barettino “Oro Bianco” per la colazione con brioche alla crema di pistacchio e granita al limone (con supplemento di classica brioscina da inzuppare). Ancora qualche foto alle saline, illuminate da un sole che cerca di farsi spazio tra le nuvole spostate dal vento freddo, e poi ripartiamo verso Mazara del Vallo.
 Ci fermiamo solo a Petrosino alla Cantina Sociale omonima, dove ne approfittiamo per fare incetta di Nero D’Avola e Grillo (spaccio vini adiacente), e un boccione di marsala puro da 5 litri a prezzi che nemmeno all’hard discount più scadente (e questo almeno è buono!) poi ripartiamo.
Ci fermiamo solo a Petrosino alla Cantina Sociale omonima, dove ne approfittiamo per fare incetta di Nero D’Avola e Grillo (spaccio vini adiacente), e un boccione di marsala puro da 5 litri a prezzi che nemmeno all’hard discount più scadente (e questo almeno è buono!) poi ripartiamo. Arriviamo in città a ridosso dell’ora di pranzo attraverso il Lungomare Giuseppe Mazzini e parcheggiamo al porto, dove un parcheggiatore abusivo ci comunica che non si può stare, nonostante il divieto per camper specifica che “non si può sostare in atto di campeggio”, quindi con tavolini e quant’altro. Alla fine, con 2,00 € ce lo togliamo dalle balle (certi, peraltro, che darà un’occhiata ai nostri veicoli senza fare storie!) e andiamo alla ricerca del cous cous per il pranzo.
Sì, lo sappiamo anche noi che non bisogna incentivare l’abusivismo, ma che facciamo? L’alternativa è inimicarceli in tempo zero e magari ritrovarci qualche sorpresina al ritorno!
Andiamo avanti.
A trecento metri daPiazza della Repubblica, su cui si affacciano gli archi delPalazzo Diocesano e la maestosa Cattedrale del Santissimo Salvatore(chiusa!), c’è “Alla Kasbah”, tipico nome da trattoria con specialità maghrebine. Decidiamo di entrare e fermarci senza temporeggiare: tra i vari piatti di pesce, ecco apparire il cous cous tanto agognato. Nel complesso un 7 ½: porzioni abbondanti (tanto che salto la cena a piè pari!) cous cous buono… il cameriere poco sorridente, ma pazienza!
Arriviamo in città a ridosso dell’ora di pranzo attraverso il Lungomare Giuseppe Mazzini e parcheggiamo al porto, dove un parcheggiatore abusivo ci comunica che non si può stare, nonostante il divieto per camper specifica che “non si può sostare in atto di campeggio”, quindi con tavolini e quant’altro. Alla fine, con 2,00 € ce lo togliamo dalle balle (certi, peraltro, che darà un’occhiata ai nostri veicoli senza fare storie!) e andiamo alla ricerca del cous cous per il pranzo.
Sì, lo sappiamo anche noi che non bisogna incentivare l’abusivismo, ma che facciamo? L’alternativa è inimicarceli in tempo zero e magari ritrovarci qualche sorpresina al ritorno!
Andiamo avanti.
A trecento metri daPiazza della Repubblica, su cui si affacciano gli archi delPalazzo Diocesano e la maestosa Cattedrale del Santissimo Salvatore(chiusa!), c’è “Alla Kasbah”, tipico nome da trattoria con specialità maghrebine. Decidiamo di entrare e fermarci senza temporeggiare: tra i vari piatti di pesce, ecco apparire il cous cous tanto agognato. Nel complesso un 7 ½: porzioni abbondanti (tanto che salto la cena a piè pari!) cous cous buono… il cameriere poco sorridente, ma pazienza!  Il segno più evidente è, come accennato, l'impronta islamica del tracciato viario dell'antica città araba (la Kasbah, appunto), vicoli e strade piccole e tortuose, che si dipartono da un asse centrale e portano a numerosi cortili, dove si aprono gli accessi alle abitazioni.
Non dimentichiamo l’Arco Normanno, che fa bella mostra (seppur piccolo e cadente) a fianco ad una scalinata con alzate decorate in maioliche che porta giù al lungomare. Tornando indietro dal tour dei vicoli, non manco di fare un brevissimo giro al chiostro del Collegio dei Gesuiti in Piazza Plebiscito, di fronte al famoso Museo del Satiro Danzante (museo archeologico della città) e soprattutto all’affascinante Chiesa di Sant'Ignazio, di cui è rimasto solo il prospetto, in seguito al crollo del tetto avvenuto nel 1993.
Il segno più evidente è, come accennato, l'impronta islamica del tracciato viario dell'antica città araba (la Kasbah, appunto), vicoli e strade piccole e tortuose, che si dipartono da un asse centrale e portano a numerosi cortili, dove si aprono gli accessi alle abitazioni.
Non dimentichiamo l’Arco Normanno, che fa bella mostra (seppur piccolo e cadente) a fianco ad una scalinata con alzate decorate in maioliche che porta giù al lungomare. Tornando indietro dal tour dei vicoli, non manco di fare un brevissimo giro al chiostro del Collegio dei Gesuiti in Piazza Plebiscito, di fronte al famoso Museo del Satiro Danzante (museo archeologico della città) e soprattutto all’affascinante Chiesa di Sant'Ignazio, di cui è rimasto solo il prospetto, in seguito al crollo del tetto avvenuto nel 1993.  Riprendiamo la marcia non prima di aver fatto una breve sosta all’Eurospin per acquisto generi prima necessità (crocchette gatto, orzo… e Galatine per me!) ed arriviamo al b&b Athena , lungo la SP115, ad un paio di chilometri dal parco archeologico di Selinunte, che visiteremo domani. L’area campeggio è buona, immersa nel verde. Spendiamo 20,00 € con tutti i servizi (docce calde incandescenti comprese!), ci intratteniamo in chiacchiere con i simpatici gestori che si mostrano (come tutti da queste parti) molto disponibili e ci raccontano che quest’anno la stagione è stata sottotono per la Sicilia, rispetto al solito. Questa pandemia a macchia di leopardo ha confuso le idee un po’ a tutti.
Riprendiamo la marcia non prima di aver fatto una breve sosta all’Eurospin per acquisto generi prima necessità (crocchette gatto, orzo… e Galatine per me!) ed arriviamo al b&b Athena , lungo la SP115, ad un paio di chilometri dal parco archeologico di Selinunte, che visiteremo domani. L’area campeggio è buona, immersa nel verde. Spendiamo 20,00 € con tutti i servizi (docce calde incandescenti comprese!), ci intratteniamo in chiacchiere con i simpatici gestori che si mostrano (come tutti da queste parti) molto disponibili e ci raccontano che quest’anno la stagione è stata sottotono per la Sicilia, rispetto al solito. Questa pandemia a macchia di leopardo ha confuso le idee un po’ a tutti.Mercurio sgamba felice (sempre al guinzaglio!) e tenta la socializzazione con gli altri gatti del campeggio, la serata termina sistemando le foto della giornata... con i capelli lavati e la pioggia fuori.
14 ottobre – km 108778
da Selinunte a San Leone (107 km)

 Stamattina, dopo le operazioni di carico/scarico, partiamo alla volta del Parco Archeologico di Selinunte, che dista un chilometro e mezzo circa dal campeggio. Selinunte era un'antica città greca, oggi il parco archeologico più grande d'Europa. Nel sito, sull'Acropoli, vi sono alcuni templi insieme ad altre costruzioni secondarie, mentre altri templi si trovano sulla collina poco lontana, da dove entriamo noi. Molti edifici sono rovinati in seguito ai sismi avvenuti in epoca medievale, tuttavia alcuni interventi hanno permesso di ricostruire quasi completamente il Tempio di Hera.
Stamattina, dopo le operazioni di carico/scarico, partiamo alla volta del Parco Archeologico di Selinunte, che dista un chilometro e mezzo circa dal campeggio. Selinunte era un'antica città greca, oggi il parco archeologico più grande d'Europa. Nel sito, sull'Acropoli, vi sono alcuni templi insieme ad altre costruzioni secondarie, mentre altri templi si trovano sulla collina poco lontana, da dove entriamo noi. Molti edifici sono rovinati in seguito ai sismi avvenuti in epoca medievale, tuttavia alcuni interventi hanno permesso di ricostruire quasi completamente il Tempio di Hera.

Tolto il Tempio di Hera, infatti (del resto è l’angolo più fotografato dell’intero sito), il resto sono sassi che sembrano ammucchiati con la ruspa, senza alcun senso. Plance descrittive estremamente sommarie per non dire inesistenti, erbacce alte in ogni dove, senza contare la scortesia del personale alla biglietteria.
Complimenti per aver distrutto un sito di valore inestimabile.
Un po’ delusi, dopo la visita ce ne andiamo verso la costa e raggiungiamo la famosa Scala dei Turchi per l’ora di pranzo. Parcheggiamo nei pressi del Belvedere della Scala dei Turchi, in un’area a 5,00 € per le prime 4 ore. E’ anche fornita di docce e wc, all’occorrenza (a pagamento).
 Non è molto grande, supponiamo che in estate sia un delirio, ma è un’ottima soluzione per qualche foto e magari una passeggiata fino alla spiaggia (raggiungibile attraverso una scalinata presso un piccolo ristorante a 300 metri dall’area sosta).
Pic-nic vista mare sul belvedere di fronte (ci sono alcune panche in legno, un sole tiepido e una bella arietta), e poi caffè al barettino dell’area di parcheggio, dove ci scappa pure una chiacchiera con il barista. Subito dopo, io non mi lascio sfuggire la passeggiata fino alla spiaggia. Secondo le ordinanze comunali, la famosa scogliera bianca è stata sequestrata per un a diatriba con un facoltoso avvocato locale che sosteneva che la scogliera fosse di sua proprietà poiché nella zona della sua vigna: per fortuna il Comune ha vinto la causa!
Non è molto grande, supponiamo che in estate sia un delirio, ma è un’ottima soluzione per qualche foto e magari una passeggiata fino alla spiaggia (raggiungibile attraverso una scalinata presso un piccolo ristorante a 300 metri dall’area sosta).
Pic-nic vista mare sul belvedere di fronte (ci sono alcune panche in legno, un sole tiepido e una bella arietta), e poi caffè al barettino dell’area di parcheggio, dove ci scappa pure una chiacchiera con il barista. Subito dopo, io non mi lascio sfuggire la passeggiata fino alla spiaggia. Secondo le ordinanze comunali, la famosa scogliera bianca è stata sequestrata per un a diatriba con un facoltoso avvocato locale che sosteneva che la scogliera fosse di sua proprietà poiché nella zona della sua vigna: per fortuna il Comune ha vinto la causa! 
 Fermo resta che ormai le famose arrampicate sono vietate perché rovinano il delicato equilibrio naturale. La vista dalla baia sabbiosa comunque non è paragonabile comunque a quella dall’alto!
Fermo resta che ormai le famose arrampicate sono vietate perché rovinano il delicato equilibrio naturale. La vista dalla baia sabbiosa comunque non è paragonabile comunque a quella dall’alto!
da San Leone a Caltagirone (152 km)
La Valle dei Templi quindi è fondamentalmente un’immensa città, con i resti di ben undici templi, tre santuari, una grande concentrazione di necropoli ed opere idrauliche come il Giardino della Kolymbetra, fortificazioni; parte di un quartiere ellenistico romano costruito su pianta greca, l’Agorà inferiore e l’Agorà superiore. Il sito è molto grande, noi ci accontentiamo della prima parte, quella più ricca di templi.





Qualche centinaio di metri oltre, costeggiando la necropoli paleocristiana tra mandorli ed ulivi, arriviamo al Tempio della Concordia, il cui nome deriva da un'iscrizione latina ritrovata nelle vicinanze dello stesso tempio, costruito anch'esso nel V secolo a.C. Attualmente è con ogni probabilità quello meglio conservato, grazie anche al fatto che fu trasformato in tempio cristiano e consacrato nel VI secolo d.C. Da qualche anno è anche uno dei templi più fotografati del sito per la presenza di una gigantesca statua mozza in bronzo di Icaro, coricata nel terreno a lato.
Proseguo il mio tour superando Villa Aurea, fatta erigere dal generale dell’esercito inglese Alexander Hardcastle negli anni Trenta all’interno di quello che sarebbe poi diventato il sito archeologico, e parte delle fondamenta inglobano la necropoli paleocristiana. Subito dopo trovo il Tempio di Ercole, il cui culto era molto importante nell'antica Akragas. Si tratta di una delle costruzioni più antiche, fu distrutto da un terremoto ed oggi restano in piedi otto colonne. Il Tempio di Zeus Olimpio, edificato invece dopo la vittoria sui Cartaginesi per onorare Zeus, era il tempio più grande di tutto l'occidente antico e unico nell'architettura del suo genere. Era caratterizzato dalla presenza dei telamoni, immense sculture alte otto metri, raffigurazioni di Atlante che sorregge la volta celeste. Ovviamente, di questi ne sono rimasti un paio “affettati” e stesi sul terreno, ma pur sempre affascinanti.



Inizia a piovigginare, ormai sono qui da quasi tre ore, perciò mi incammino di nuovo verso l’ingresso. Prima di mezzogiorno ripartiamo e all’ora di pranzo attraversiamo il famoso Canicattì (spesso nominato per essere un posto molto dimenticato da Dio in mezzo alla Sicilia!): ci fermiamo da Lidl per il pane, approfittandone per mangiare qualcosa.
Arriviamo nei pressi di Piazza Armerina intorno alle 15:30, più precisamente alla Villa romana del Casale, a circa 4 chilometri.
 La splendida villa imperiale nel cuore romano della Sicilia, in provincia di Enna, è una magnifica dimora rurale, il cui fascino è dovuto soprattutto agli incantevoli mosaici, considerati i più belli e meglio conservati nel loro genere: frutto di un lavoro certosino fatto di immagini nitide ed emozionanti, impreziosiscono in modo significativo i resti della fastosa residenza inserita nel 1997 nella lista dei Patrimoni dell’Umanità dall'UNESCO. L'antica villa può considerarsi uno degli esempi più significativi di dimora di rappresentanza. Risalente al III Secolo d.C. la villa sarebbe appartenuta ad un esponente dell’aristocrazia senatoria romana, probabilmente un governatore di Roma; secondo alcuni studiosi fu, invece, costruita e ampliata su diretta committenza di un altissimo funzionario imperiale. Un'importante campagna di scavo condotta verso la metà del Novecento, dopo secoli di abbandono del sito, portò alla luce 3500 metri quadrati di pavimentazione a mosaico figurativo e in stile geometrico, oltre a colonne, statue, capitelli e monete.
La splendida villa imperiale nel cuore romano della Sicilia, in provincia di Enna, è una magnifica dimora rurale, il cui fascino è dovuto soprattutto agli incantevoli mosaici, considerati i più belli e meglio conservati nel loro genere: frutto di un lavoro certosino fatto di immagini nitide ed emozionanti, impreziosiscono in modo significativo i resti della fastosa residenza inserita nel 1997 nella lista dei Patrimoni dell’Umanità dall'UNESCO. L'antica villa può considerarsi uno degli esempi più significativi di dimora di rappresentanza. Risalente al III Secolo d.C. la villa sarebbe appartenuta ad un esponente dell’aristocrazia senatoria romana, probabilmente un governatore di Roma; secondo alcuni studiosi fu, invece, costruita e ampliata su diretta committenza di un altissimo funzionario imperiale. Un'importante campagna di scavo condotta verso la metà del Novecento, dopo secoli di abbandono del sito, portò alla luce 3500 metri quadrati di pavimentazione a mosaico figurativo e in stile geometrico, oltre a colonne, statue, capitelli e monete. 


 Lo stile di vita del proprietario della casa viene celebrato da questa serie di mosaici, sia a pavimento che a parete, e si manifesta con ricchezza ed eloquenza in tutti gli ambienti della casa mostrando evidenti influenze stilistiche dell'arte africana, che hanno indotto a pensare che tra i lavoratori ci fosse anche personale proveniente dall’Africa. Nei mosaici si distinguono differenti stili e cicli narrativi: uno dedicato alla mitologia e ai poemi omerici, l'altro con riferimenti alla natura e a scene di vita quotidiana dell'aristocrazia romana, come banchetti e caccia. Bella visita, molto interessante (l’ingresso costa 10,00 € e consente l’accesso ad ogni zona, visitabile comunque solo dall’alto camminando su pedane rialzate). Lasciato il parcheggio della Villa del Casale e ci dirigiamo verso Caltagirone, dove contiamo di arrivare prima di buio senza considerare il navigatore che, come sempre, ci porta a stradine, per l’esattezza dentro Piazza Armerina. Imbocchiamo una salita abbastanza ripida, dove una tipa in macchina che transita in senso opposto ci fa cenno con la mano. Rallentiamo, abbassa il finestrino: “Benvenuti a Piazza Armerina! Benvenuti, grazie per essere passati di qua! Io vivo in campagna con tre cani, ma grazie per essere arrivati fin qui e benvenuti!”
Lo stile di vita del proprietario della casa viene celebrato da questa serie di mosaici, sia a pavimento che a parete, e si manifesta con ricchezza ed eloquenza in tutti gli ambienti della casa mostrando evidenti influenze stilistiche dell'arte africana, che hanno indotto a pensare che tra i lavoratori ci fosse anche personale proveniente dall’Africa. Nei mosaici si distinguono differenti stili e cicli narrativi: uno dedicato alla mitologia e ai poemi omerici, l'altro con riferimenti alla natura e a scene di vita quotidiana dell'aristocrazia romana, come banchetti e caccia. Bella visita, molto interessante (l’ingresso costa 10,00 € e consente l’accesso ad ogni zona, visitabile comunque solo dall’alto camminando su pedane rialzate). Lasciato il parcheggio della Villa del Casale e ci dirigiamo verso Caltagirone, dove contiamo di arrivare prima di buio senza considerare il navigatore che, come sempre, ci porta a stradine, per l’esattezza dentro Piazza Armerina. Imbocchiamo una salita abbastanza ripida, dove una tipa in macchina che transita in senso opposto ci fa cenno con la mano. Rallentiamo, abbassa il finestrino: “Benvenuti a Piazza Armerina! Benvenuti, grazie per essere passati di qua! Io vivo in campagna con tre cani, ma grazie per essere arrivati fin qui e benvenuti!”Noi, un po’ perplessi, ringraziamo (se fossimo un fumetto giapponese avremmo una goccia che scende dalla testa) e proseguiamo.
 Arriviamo nella città della ceramica giusto in tempo per il tramonto e ci fermiamo in un buon parcheggio vicino alla circonvallazione (un po’ rumoroso per le macchine che passano, ma illuminato e con altri due camper).
Arriviamo nella città della ceramica giusto in tempo per il tramonto e ci fermiamo in un buon parcheggio vicino alla circonvallazione (un po’ rumoroso per le macchine che passano, ma illuminato e con altri due camper).La serata finisce con assaggi di zibibbo e marsala!
Venerdì 16 ottobre – km 109037
da Caltagirone a Ragusa (152 km)
 Stamattina l’aria è frizzantina ma promette bene: i camion della spazzatura hanno iniziato a caricare i bidoni alle 6 del mattino, e a seguire gli scampanacci della chiesa. Ovviamente, Mercurio non è da meno e inizia il suo parkour sui mobili prima delle 7.
Stamattina l’aria è frizzantina ma promette bene: i camion della spazzatura hanno iniziato a caricare i bidoni alle 6 del mattino, e a seguire gli scampanacci della chiesa. Ovviamente, Mercurio non è da meno e inizia il suo parkour sui mobili prima delle 7. Dopo il caffè, partiamo alla scoperta di questa cittadina: gli operatori ecologici, molto cortesi, ci spiegano la strada più breve per arrivare in centro e ci dicono che il parcheggio è tranquillo e che ci saranno loro fino quasi a mezzogiorno, pertanto butteranno eventualmente anche un occhio ai camper. Saliamo una prima breve scalinata e ci infiliamo in un vicolo terribilmente fatiscente. Interessanti comunque le targhe dei monumenti, interamente realizzate in ceramica dipinta a mano, come quella del Palazzo dell’Aquila, sulla Piazza del Municipio. A brevissima distanza, la Basilica di San Giuliano, dall’aria più rinascimentale e barocca rispetto alle città fatte finora (del resto stiamo scendendo nel Ragusano, ovvero in quella parte di Sicilia che più si avvicina alla mia idea di architettura!).



Arrivo alla Basilica di San Giacomo, purtroppo chiusa, e scendo fino ai Giardini Pubblici. Il centro storico si gira bene, i punti di interesse sono abbastanza concentrati ma la pavimentazione è un po’ dissestata. La parte più bella comunque è quella dei Giardini Pubblici: una prima parte è ricca di vegetazione, tra cui spiccano palme e alcune specie di aloe.


Attraversando la parte alberata si arriva ad un grosso piazzale con un gazebo rivestito in ceramica colorata, estremamente fotogenico, e una bellissima fontana con piccole aiuolette rivestite in ceramica (anche se andrebbero un po’ sistemate)… e ci nuotano anche un paio di oche!

 La giornata soleggiata poi rende tutto ancora più bello, quindi perdo facilmente tempo a fare foto. Torno al camper, oggi mangiamo abbastanza presto, e alle 14:00 siamo già di nuovo in marcia verso Ragusa. Per l’esattezza, iniziamo la visita da Ragusa Ibla, l’antico centro storico della città, espressione massima del barocco del sud est della Sicilia. Dopo il terremoto di fine Seicento infatti, la città di Ragusa antica fu ricostruita attuando cantieri che produssero opere, edifici e monumenti di gusto tardo barocco. Qui sono presenti ben 14 dei 18 monumenti della città di Ragusa oggi iscritti nel patrimonio dell'umanità.
La giornata soleggiata poi rende tutto ancora più bello, quindi perdo facilmente tempo a fare foto. Torno al camper, oggi mangiamo abbastanza presto, e alle 14:00 siamo già di nuovo in marcia verso Ragusa. Per l’esattezza, iniziamo la visita da Ragusa Ibla, l’antico centro storico della città, espressione massima del barocco del sud est della Sicilia. Dopo il terremoto di fine Seicento infatti, la città di Ragusa antica fu ricostruita attuando cantieri che produssero opere, edifici e monumenti di gusto tardo barocco. Qui sono presenti ben 14 dei 18 monumenti della città di Ragusa oggi iscritti nel patrimonio dell'umanità. Ci fermiamo presso il parcheggio pubblico (gratuito) abbastanza ampio proprio all’inizio della cittadina, dove ci sono anche altri camper (a fine giornata saremo ben sei!), ed io mi lancio subito alla scoperta di questo borgo antico, che mi è piaciuto già dai tornanti che scendevano e ci hanno portati fino qui. Si vede Ragusa Ibla, e in alto si vedono le case del nuovo nucleo abitato di Ragusa. Curiosa, questa città divisa in due parti: nel 1866 il quartiere si staccò amministrativamente dal resto della città diventando comune autonomo col nome di Ragusa Inferiore, nome che mantenne fino agli anni Venti, quando fu cambiato in Ragusa Ibla. Nel 1927, in occasione dell'elevazione a capoluogo di provincia della città di Ragusa, i due comuni furono riuniti. All’ufficio turistico prendo subito una piantina ed inizio ad orientarmi: il primo edificio che mi trovo davanti su Piazza della Repubblica (subito sopra il nostro parcheggio) è la Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio.
Ci fermiamo presso il parcheggio pubblico (gratuito) abbastanza ampio proprio all’inizio della cittadina, dove ci sono anche altri camper (a fine giornata saremo ben sei!), ed io mi lancio subito alla scoperta di questo borgo antico, che mi è piaciuto già dai tornanti che scendevano e ci hanno portati fino qui. Si vede Ragusa Ibla, e in alto si vedono le case del nuovo nucleo abitato di Ragusa. Curiosa, questa città divisa in due parti: nel 1866 il quartiere si staccò amministrativamente dal resto della città diventando comune autonomo col nome di Ragusa Inferiore, nome che mantenne fino agli anni Venti, quando fu cambiato in Ragusa Ibla. Nel 1927, in occasione dell'elevazione a capoluogo di provincia della città di Ragusa, i due comuni furono riuniti. All’ufficio turistico prendo subito una piantina ed inizio ad orientarmi: il primo edificio che mi trovo davanti su Piazza della Repubblica (subito sopra il nostro parcheggio) è la Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio.




 Qualche centinaio di metri oltre, imbocco il fotografatissimo vicolo dal quale si intravede la cupola del Duomo di San Giorgio, il principale luogo di culto cattolico di Ragusa e uno dei monumenti più importanti della città. La chiesa madre intitolata al patrono della città, prima del terremoto di fine Seicento sorgeva all'estremità est dell'abitato, nei pressi dell'attuale Giardino Ibleo (dove più tardi ritrovo infatti il Portale quattrocentesco, di stile gotico spagnolo, unica vestigia rimasta dell'antico tempio). L'ultima modifica del complesso risale al 1890, quando venne realizzata l'inferriata che cinge la scalinata. Il Duomo è stato immortalato in innumerevoli film e serie televisive tra cui Kaos, Il commissario Montalbano e la seconda serie di L'onore e il rispetto.
Poco più in là del Duomo, la Chiesa di San Giacomo, la cui facciata ricurva ricorda quella del Duomo (infatti fu progettata dallo stesso architetto Rosario Gagliardi). Le statue di quattro santi coronano il portale e altre figure di santi campeggiano nella finestra superiore con il frontone riccamente decorato che affianca il vecchio Municipio in una piazzetta.
Qualche centinaio di metri oltre, imbocco il fotografatissimo vicolo dal quale si intravede la cupola del Duomo di San Giorgio, il principale luogo di culto cattolico di Ragusa e uno dei monumenti più importanti della città. La chiesa madre intitolata al patrono della città, prima del terremoto di fine Seicento sorgeva all'estremità est dell'abitato, nei pressi dell'attuale Giardino Ibleo (dove più tardi ritrovo infatti il Portale quattrocentesco, di stile gotico spagnolo, unica vestigia rimasta dell'antico tempio). L'ultima modifica del complesso risale al 1890, quando venne realizzata l'inferriata che cinge la scalinata. Il Duomo è stato immortalato in innumerevoli film e serie televisive tra cui Kaos, Il commissario Montalbano e la seconda serie di L'onore e il rispetto.
Poco più in là del Duomo, la Chiesa di San Giacomo, la cui facciata ricurva ricorda quella del Duomo (infatti fu progettata dallo stesso architetto Rosario Gagliardi). Le statue di quattro santi coronano il portale e altre figure di santi campeggiano nella finestra superiore con il frontone riccamente decorato che affianca il vecchio Municipio in una piazzetta.








Sabato 17 ottobre – km 109105
da Ragusa a Marina di Ragusa (68 km)
Stamattina, con una bella aria fresca, andiamo alla scoperta di Ragusa, o meglio, Ragusa “nuova”. Lascio i miei alla fermata del bus a Piazza della Repubblica, subito sopra il nostro parcheggio, ed imbocco la lunga scalinata che mi porta fino alla Chiesa di Santa Maria alle Scale dopo circa 400 gradini!

 Il panorama di Ragusa Ibla da qui è favoloso e sicuramente vale la pena arrivarci (in bus o a piedi!). Faccio un giro, passo davanti a Piazza Matteotti con il bell’edificio delle Poste e la fontana, poi ritrovo i miei sotto alla Cattedrale di San Giovanni Battista, che sorge al centro dell’abitato di Ragusa nuova dopo il sisma di fine Seicento che rase praticamente al suolo Ragusa Ibla (fu ricostruita in soli 4 mesi!). Circa vent’anni dopo, iniziò la costruzione nello stesso sito di una chiesa più grande. Il tempio fu solennemente consacrato nel 1778, e qualche anno più tardi fu innalzata la cupola, ricoperta poi all'esterno da lamine di rame nel secolo scorso. Nel 1848 fu rinnovata la pavimentazione mediante l'utilizzo di lastre di pietra pece, impreziosite da intarsi geometrici in pietra calcarea. Nel 1950 il tempio fu elevato a Cattedrale e dal 2002 è inserita tra i monumenti cittadini del circuito delle Città tardo barocche del Val di Noto nella lista di patrimoni UNESCO. Anche qui si entra gratuitamente con un’offerta, come nelle chiese visitate ieri. Esco e raggiungo i due ponti sulla valle ragusana e sul piccolo fiume, poi torno indietro, non prima di essermi persa (come al solito!) nei vicoli.
Il panorama di Ragusa Ibla da qui è favoloso e sicuramente vale la pena arrivarci (in bus o a piedi!). Faccio un giro, passo davanti a Piazza Matteotti con il bell’edificio delle Poste e la fontana, poi ritrovo i miei sotto alla Cattedrale di San Giovanni Battista, che sorge al centro dell’abitato di Ragusa nuova dopo il sisma di fine Seicento che rase praticamente al suolo Ragusa Ibla (fu ricostruita in soli 4 mesi!). Circa vent’anni dopo, iniziò la costruzione nello stesso sito di una chiesa più grande. Il tempio fu solennemente consacrato nel 1778, e qualche anno più tardi fu innalzata la cupola, ricoperta poi all'esterno da lamine di rame nel secolo scorso. Nel 1848 fu rinnovata la pavimentazione mediante l'utilizzo di lastre di pietra pece, impreziosite da intarsi geometrici in pietra calcarea. Nel 1950 il tempio fu elevato a Cattedrale e dal 2002 è inserita tra i monumenti cittadini del circuito delle Città tardo barocche del Val di Noto nella lista di patrimoni UNESCO. Anche qui si entra gratuitamente con un’offerta, come nelle chiese visitate ieri. Esco e raggiungo i due ponti sulla valle ragusana e sul piccolo fiume, poi torno indietro, non prima di essermi persa (come al solito!) nei vicoli.Decisamente la parte nuova di Ragusa è meno “monumentale” del borgo antico, ma la conformazione stessa della città è davvero molto interessante: è appoggiata alla roccia, scivola giù dall’alto verso il basso, e nella parte alta ci sono ponti storici su una stretta vallata. Per raggiungere Ragusa Ibla ci sono sei tornanti che scendono, e per raggiungere Ragusa nuova ce ne sono altri cinque o sei che risalgono. Va da sé che i punti panoramici sono molteplici… e mozzafiato.
 Riprendiamo il camper, intenzionati a fare operazioni di carico/scarico da qualche parte in zona prima di pranzo. La prima area camper service è a Largo Caduti sul Lavoro, dove scarichiamo nere e grigie e saremmo pronti a ricaricare, se non finisse improvvisamente l’acqua! Un po’ perplessi, raggiungiamo quindi (con le indicazioni forniteci da un autoctono a spasso col cane che ci ha anche detto “mah… stranissimo, l’acqua qui non è mai mancata un giorno!” – che fortuna) lo stadio in Via Cartia, con l’area di sosta di fronte: in realtà fa abbastanza schifo, è utile giusto per emergenze (se si è proprio alla canna del gas, si può valutare): lo spazio di parcheggio è minimo (sconsigliatissimo per dormire!), le griglie sono trasandate e sporche, il flusso d’acqua dal rubinetto è minimo e ci rende impossibile fare un carico decente. Conclusione: un’ora e mezza persa! Alla fine ci fermiamo quindi dove capita per un rapido pranzo con scaccia ragusana (prodotto tipico locale) e riprendiamo la marcia verso il
Riprendiamo il camper, intenzionati a fare operazioni di carico/scarico da qualche parte in zona prima di pranzo. La prima area camper service è a Largo Caduti sul Lavoro, dove scarichiamo nere e grigie e saremmo pronti a ricaricare, se non finisse improvvisamente l’acqua! Un po’ perplessi, raggiungiamo quindi (con le indicazioni forniteci da un autoctono a spasso col cane che ci ha anche detto “mah… stranissimo, l’acqua qui non è mai mancata un giorno!” – che fortuna) lo stadio in Via Cartia, con l’area di sosta di fronte: in realtà fa abbastanza schifo, è utile giusto per emergenze (se si è proprio alla canna del gas, si può valutare): lo spazio di parcheggio è minimo (sconsigliatissimo per dormire!), le griglie sono trasandate e sporche, il flusso d’acqua dal rubinetto è minimo e ci rende impossibile fare un carico decente. Conclusione: un’ora e mezza persa! Alla fine ci fermiamo quindi dove capita per un rapido pranzo con scaccia ragusana (prodotto tipico locale) e riprendiamo la marcia verso il  Castello di Donnafugata, residenza baronale dell’Ottocento.
Castello di Donnafugata, residenza baronale dell’Ottocento.La prima costruzione del castello sembra dovuta ai Chiaramonte, conti di Modica nel XIV Secolo.. Nel XV Secolo potrebbe essere stata una delle residenze di tal Bernardo Cabrera, all'epoca gran giustiziere del Regno di Sicilia, ma bisogna comunque tenere presente che i dati precedenti al Settecento riguardanti il castello sono solo il frutto della leggenda quattrocentesca, quindi privi di riscontro storico. Il feudo fu acquistato nel 1648 dal barone di Serre, che ne fece una masseria fortificata. Nel corso del tempo si trasformò in una casina neoclassica e in castello neogotico, ma la maggior parte della costruzione si deve al discendente, il barone Corrado Arezzo, eclettico uomo di studi e politico che ne modificò la struttura nell’Ottocento. Dopo anni di incuria ed abbandono, nel 1982 venne acquistato dal Comune di Ragusa che, dopo lunghi lavori di restauro, lo ha reso nuovamente fruibile. Il biglietto d’ingresso costa 6,00 € (la metà per gli over 65), gli interni sono curati, non pacchiani, ma soprattutto i miei occhi apprezzano molto gli accostamenti cromatici (quasi sempre armonici).



Una bella terrazza illuminata dal sole circonda il castello su due lati, e a lato del giardino con grossi alberi c’è un piccolo labirinto in pietra, in cui tentiamo di addentrarci ma, onde evitare di perderci, non restiamo a lungo!
 Riprendiamo allora il camper e ci dirigiamo verso Punta Secca, in realtà più che altro per fare qualche foto alla casa del commissario Montalbano, dato che, essendo un b&b, non è possibile entrare solo per visita! Tra l’altro, quella che oggi appare come una bellissima villetta, agli inizi del ‘900 era invece un magazzino per il pesce: le barche di Punta Secca venivano utilizzate per pescare sarde e acciughe che venivano poi trattate, salate e conservate nella stanza che ora si trova di fronte alla veranda, ad essiccare. All’inizio del secolo scorso, il nonno dell’attuale proprietario e grande amante del mare, acquistò l’antico edificio, precario ed alto quasi quattro metri e che oggi è diventata una bellissima abitazione nonché set di una fiction pluripremiata. Leonardo Sciascia e Gesualdo Bufalino sono solo alcuni degli illustri nomi che nel corso degli anni hanno frequentato questo l’incantevole posto, ma fu Elvira Sellerio (fondatrice della nota casa editrice palermitana negli anni Settanta) che cambiò le sorti di questa dimora. Aveva visto il villino e se ne era innamorata, e uno dei tanti pomeriggi che trascorse a Punta Secca, iniziò a ragionare sull’ambizioso progetto di trasformare in un film le storie di un commissario siciliano, un complesso personaggio nato dalla penna di un allora quasi sconosciuto Andrea Camilleri. Lo scrittore fu così invitato a Punta Secca: rimase molto colpito dalla zona degli Iblei e dal villino, e alla fine si convinse. Dopo qualche perplessità anche da parte dei proprietari, potremmo dire che “si fecero persuasi” tutti, e così la bella casa di Corso Aldo Moro a Punta Secca è diventata la villetta sul mare di Montalbano, a Marinella.
Riprendiamo allora il camper e ci dirigiamo verso Punta Secca, in realtà più che altro per fare qualche foto alla casa del commissario Montalbano, dato che, essendo un b&b, non è possibile entrare solo per visita! Tra l’altro, quella che oggi appare come una bellissima villetta, agli inizi del ‘900 era invece un magazzino per il pesce: le barche di Punta Secca venivano utilizzate per pescare sarde e acciughe che venivano poi trattate, salate e conservate nella stanza che ora si trova di fronte alla veranda, ad essiccare. All’inizio del secolo scorso, il nonno dell’attuale proprietario e grande amante del mare, acquistò l’antico edificio, precario ed alto quasi quattro metri e che oggi è diventata una bellissima abitazione nonché set di una fiction pluripremiata. Leonardo Sciascia e Gesualdo Bufalino sono solo alcuni degli illustri nomi che nel corso degli anni hanno frequentato questo l’incantevole posto, ma fu Elvira Sellerio (fondatrice della nota casa editrice palermitana negli anni Settanta) che cambiò le sorti di questa dimora. Aveva visto il villino e se ne era innamorata, e uno dei tanti pomeriggi che trascorse a Punta Secca, iniziò a ragionare sull’ambizioso progetto di trasformare in un film le storie di un commissario siciliano, un complesso personaggio nato dalla penna di un allora quasi sconosciuto Andrea Camilleri. Lo scrittore fu così invitato a Punta Secca: rimase molto colpito dalla zona degli Iblei e dal villino, e alla fine si convinse. Dopo qualche perplessità anche da parte dei proprietari, potremmo dire che “si fecero persuasi” tutti, e così la bella casa di Corso Aldo Moro a Punta Secca è diventata la villetta sul mare di Montalbano, a Marinella. Il grande successo della fiction ha rilanciato il territorio ragusano come mai prima era accaduto. Il settore turistico ha subito un’impennata e ogni anno migliaia di persone giungono da ogni parte d’Italia e del mondo per seguire le orme di Montalbano. Dal 2003 la casa è stata trasformata in un’accogliente b&b che ha inoltre preso il nome “La casa di Montalbano”. Ovviamente nei giorni delle riprese la struttura resta chiusa al pubblico, ma nel resto dell’anno è possibile soggiornare in una delle stanze disponibili.
Il grande successo della fiction ha rilanciato il territorio ragusano come mai prima era accaduto. Il settore turistico ha subito un’impennata e ogni anno migliaia di persone giungono da ogni parte d’Italia e del mondo per seguire le orme di Montalbano. Dal 2003 la casa è stata trasformata in un’accogliente b&b che ha inoltre preso il nome “La casa di Montalbano”. Ovviamente nei giorni delle riprese la struttura resta chiusa al pubblico, ma nel resto dell’anno è possibile soggiornare in una delle stanze disponibili.Con il sole che tramonta arriviamo a Marina di Ragusa e ci fermiamo presso l’area di sosta “Il Carrubo”, un bel piazzale pulito e molto ordinato, con carico e scarico ed eventuale allaccio elettrico. Il gestore è gentilissimo, sorridente e cortese, e noi siamo tranquilli perché la libera il weekend, memori della scorsa settimana, è abbastanza rischiosa dal punto di vista dei rumori molesti!
Sabato 18 ottobre – km 109157
da Marina di Ragusa a Modica (52 km)
Oggi la giornata si preannuncia tiepida e soleggiata. Dopo le operazioni di carico/scarico salutiamo i gentilissimi gestori e ci spostiamo a Scicli, comune ragusano di venticinquemila anime, parte dei patrimoni dell’umanità della Val di Noto, dove riusciamo a parcheggiare nei pressi di un Istituto Comprensorio in Via Vasco de Gama, all’incrocio con Corso Umberto I.

 La visita inizia da Piazza Busacca, con la Chiesa della Madonna del Carmine, e poco oltre la bellissima piazza che si apre su Via Francesco Mormino Penna, dove troviamo il Municipio, ovvero il “riadattato” famosissimo Commissariato di Montalbano, e la Chiesa di San Giovanni Evangelista. L’attuale chiesa, risultato di numerose ricostruzioni effettuata a partire dalla prima metà del Settecento fino ai primi anni del XIX Secolo grazie anche alle donazioni di nobili privati, presenta una facciata concavo-convessa a tre ordini. Svetta sulla via pavimentata e sullo spettatore in modo imponente, e forse per la collocazione in uno spazio ristretto rivela più delle altre i caratteri sontuosi del barocco. I lavori di costruzione iniziarono a metà Settecento, mentre l’ultima fase della decorazione interna, con stucchi e dorature, fu eseguita un secolo dopo. A tal proposito, dietro alla sua splendida facciata tardo-barocca (come tutta la cittadina di Scicli), nasconde anche altre bellezze, su tutte il Cristo di Burgos (famoso per essere l’unico “Cristo con la gonna”, interessante opera spagnola, anche se di fatto non è una gonna ma una lunga tunica) e il ricco soffitto affrescato. La visita è alquanto breve ma raccomandata (ingresso ad offerta).
La visita inizia da Piazza Busacca, con la Chiesa della Madonna del Carmine, e poco oltre la bellissima piazza che si apre su Via Francesco Mormino Penna, dove troviamo il Municipio, ovvero il “riadattato” famosissimo Commissariato di Montalbano, e la Chiesa di San Giovanni Evangelista. L’attuale chiesa, risultato di numerose ricostruzioni effettuata a partire dalla prima metà del Settecento fino ai primi anni del XIX Secolo grazie anche alle donazioni di nobili privati, presenta una facciata concavo-convessa a tre ordini. Svetta sulla via pavimentata e sullo spettatore in modo imponente, e forse per la collocazione in uno spazio ristretto rivela più delle altre i caratteri sontuosi del barocco. I lavori di costruzione iniziarono a metà Settecento, mentre l’ultima fase della decorazione interna, con stucchi e dorature, fu eseguita un secolo dopo. A tal proposito, dietro alla sua splendida facciata tardo-barocca (come tutta la cittadina di Scicli), nasconde anche altre bellezze, su tutte il Cristo di Burgos (famoso per essere l’unico “Cristo con la gonna”, interessante opera spagnola, anche se di fatto non è una gonna ma una lunga tunica) e il ricco soffitto affrescato. La visita è alquanto breve ma raccomandata (ingresso ad offerta).



In fondo alla via, l’Antica Farmacia Cartia e la Chiesa di San Michele Arcangelo. Passiamo davanti al Palazzo Beneventano infilandoci nei vicoli color ocra adornati da piante e raggiungiamo la Chiesa Madre di Sant’Ignazio di Loyola. Ultima tappa, la Chiesa di San Bartolomeo, altro esempio di tardo-barocco con un interno a tre navate più neoclassico, con stucchi dipinti e molto armonico nella scelta dei colori (tra l’altro gli interni sono stati “ripuliti” una quindicina di anni fa, quindi i colori sono estremamente brillanti).




Lascio poi i miei e raggiungo il caratteristico Chiafura, un antico quartiere interamente scavato nella roccia. Anticamente l'area era adibita a necropoli, fu progressivamente trasformata in abitato trogloditico nel periodo attorno all’VIII Secolo d.C. ed occupata praticamente fino agli anni Cinquanta, in stile materano insomma. Il sito, diventato oggi un parco archeologico, è visitabile nell’ambito del circuito “La via dei Tesori” (monumenti aperti con un piccolo contributo alcuni weekend l’anno). Ne approfitto dunque per vedere, al costo di 3,00 € con visita guidata (tra l’altro la nostra guida è una ragazza graziosissima e molto simpatica), alcune delle 78 case-grotta, per capire un po' la vita in questi tuguri. Pare che riuscisseroa a stiparsi anche 10 persone e un paio di asini in uno spazio di 20 metri quadrati... e non stento acredere che le condizioni igieniche fossero disastrose.

Recupero i miei a pochi passi dal camper e ripartiamo.
Dieci chilometri più tardi, dopo aver guidato lungo alcuni tornanti che scoprono il belvedere su Scicli, siamo a Modica. Abbiamo selezionato un parcheggio di fronte alla CRAI, in Piazzale Falcone e Borsellino, vicino all’Hotel Principe d’Aragona, che rimane abbastanza comodo e a breve distanza dal centro storico. Iniziamo il tour dalla Chiesa di San Pietro, bella sia all’esterno che all’interno, e poco più avanti la Chiesa di Santa Maria del Soccorso.


Abbandono i miei che salgono sul trenino turistico e mi infilo in un negozio per fare scorta di cioccolato modicano.
 Modica è infatti famosa per essere la patria di questo cioccolato unico che si ottiene da una particolare lavorazione "a freddo" che esclude la fase del concaggio. Il concaggio è il mescolare per tempi molto lunghi la miscela di ingredienti in apposite impastatrici (dette conche) aggiungendo eventualmente dell'altro burro di cacao, il tutto a temperatura controllata sufficiente a mantenere la miscela liquida ed omogenea, rompendo tutti i grumi. Ecco, la lavorazione del cioccolato modicano è esattamente il contrario, e deriva da un’antica ricetta messicana, quella del “xocoatl”: la forza del prodotto consiste nella semplicità della lavorazione, proprio nella masticazione granulosa e friabile grazie sia alla mancanza della fase di concaggio che allo zucchero che si presenta in cristalli, e nell'assenza di sostanze estranee. Per molti ma non per tutti, soprattutto perché il cioccolato è DAVVERO cioccolato! Tra l’altro solo un paio di anni fa il cioccolato di Modica ha finalmente ottenuto dall’Unione Europea il riconoscimento di Indicazione Geografica Protetta!
Modica è infatti famosa per essere la patria di questo cioccolato unico che si ottiene da una particolare lavorazione "a freddo" che esclude la fase del concaggio. Il concaggio è il mescolare per tempi molto lunghi la miscela di ingredienti in apposite impastatrici (dette conche) aggiungendo eventualmente dell'altro burro di cacao, il tutto a temperatura controllata sufficiente a mantenere la miscela liquida ed omogenea, rompendo tutti i grumi. Ecco, la lavorazione del cioccolato modicano è esattamente il contrario, e deriva da un’antica ricetta messicana, quella del “xocoatl”: la forza del prodotto consiste nella semplicità della lavorazione, proprio nella masticazione granulosa e friabile grazie sia alla mancanza della fase di concaggio che allo zucchero che si presenta in cristalli, e nell'assenza di sostanze estranee. Per molti ma non per tutti, soprattutto perché il cioccolato è DAVVERO cioccolato! Tra l’altro solo un paio di anni fa il cioccolato di Modica ha finalmente ottenuto dall’Unione Europea il riconoscimento di Indicazione Geografica Protetta!
 Risalgo Strada Castello ed arrivo proprio sotto lo sperone roccioso dove se ne sta arroccata la Torretta dell’Orologio, che si staglia bianca sullo sfondo di un cielo grigio piombo che fa quasi impressione. Mi affaccio al cancello del Castello dei Conti, edificio difensivo con vista sulla città, ma guarda caso, oggi che è domenica è chiuso. Mai una gioia. Cammina cammina lungo Corso Francesco Crispi, arrivo dietro all’imponente Duomo di San Giorgio, e quando dico “imponente”, lo dico con cognizione di causa! Innanzitutto, arrivando da questo lato, visito prima gli interni, e già da qui è difficile non restare colpiti: dietro l’altare maggiore si trova un polittico composto da 9 riquadri, con raffigurazioni di santi. Elegante ed estrema, mente ricca è l’ampia cornice in legno scolpito e dorato con elementi manieristici. Tra le opere più significative, anche una meridiana solare, disegnata dal matematico Armando Perini nel 1895, che segna sul pavimento il mezzogiorno locale.
Risalgo Strada Castello ed arrivo proprio sotto lo sperone roccioso dove se ne sta arroccata la Torretta dell’Orologio, che si staglia bianca sullo sfondo di un cielo grigio piombo che fa quasi impressione. Mi affaccio al cancello del Castello dei Conti, edificio difensivo con vista sulla città, ma guarda caso, oggi che è domenica è chiuso. Mai una gioia. Cammina cammina lungo Corso Francesco Crispi, arrivo dietro all’imponente Duomo di San Giorgio, e quando dico “imponente”, lo dico con cognizione di causa! Innanzitutto, arrivando da questo lato, visito prima gli interni, e già da qui è difficile non restare colpiti: dietro l’altare maggiore si trova un polittico composto da 9 riquadri, con raffigurazioni di santi. Elegante ed estrema, mente ricca è l’ampia cornice in legno scolpito e dorato con elementi manieristici. Tra le opere più significative, anche una meridiana solare, disegnata dal matematico Armando Perini nel 1895, che segna sul pavimento il mezzogiorno locale. Esco, inizio a scendere i gradini. Mi volto e mi trovo davanti questa sinuosa signora color ocra, con i suoi accostamenti di forme concave e convesse, tipiche del barocco. Oltre ad essere il simbolo della città di Modica, è infatti da molti considerato anche il monumento simbolo del barocco in Sicilia.
Esco, inizio a scendere i gradini. Mi volto e mi trovo davanti questa sinuosa signora color ocra, con i suoi accostamenti di forme concave e convesse, tipiche del barocco. Oltre ad essere il simbolo della città di Modica, è infatti da molti considerato anche il monumento simbolo del barocco in Sicilia.


E’ posto in cima ad una pittoresca scalinata di 260 gradini su più ripiani (simile alla scalinata di Trinità dei Monti), adornata di bouganvilles, dalla quale si scopre un bel panorama sulla città. Scendo la lunga scalinata un gradino alla volta, come per assaporarla, poi mi volto ancora, faccio cinquanta foto. Mi perdo nei vicoletti bianchi e ripeto a me stessa che adoro questa architettura. Risalgo Corso Umberto I e mi infilo in alcuni vicoletti per ammirare la città sull’altro lato, finché non ritrovo i miei nei pressi del camper che non è ancora buio. Per la notte ci spostiamo invece nel parcheggio adiacente alla stazione (un po’ più defilato rispetto al precedente) anche se non sarà la scelta migliore dato un discreto viavai… almeno fino a mezzanotte!
Lunedì 19 ottobre - Km 109198
da Modica a Marzamemi (41 km)
Oggi giornata dedicata alla costa e alle piccole soste per ammirare il mare, sperando che il tempo ci assista. Lasciamo quindi il parcheggio (che stanotte dopo una certa ora si è calmato!) in direzione Mediterraneo, non prima di aver fatto rifornimento al supermercato. Prima tappa Fornace Penna in Contrada Pisciotto, poco distante da Pozzallo.

Si tratta di una vecchia fornace dell’Ottocento, costruita in posizione strategica vicino al mare per favorire l’arrivo delle merci e vicino ad un corso d’acqua che all’epoca era abbondante. Fu abbandonata negli anni Venti, dopo che un incendio la danneggiò irrimediabilmente: da allora, da un secolo, la natura si è ripresa ciò che le apparteneva, rendendo il vecchio edificio estremamente suggestivo.



Tra l’altro, la pietra con cui è costruito appare luminosa, non è rimasta traccia del fumo, e ricorda molto le cattedrali diroccate che abbiamo visto durante il nostro viaggio in UK, infatti la chiamano “la cattedrale sul mare”. Abbiamo anche il privilegio di vedere lo yacht di un famoso magnate russo (che ha pochi soldi!) ormeggiato a largo della costa: da lontano sembra già enorme, un tipo che sta facendo delle foto presso la fornace mi racconta che si vede spesso da queste parti e che è un bolide di circa 350 milioni di euro. Poracci insomma. Seconda tappa, Punta di Ciriga, lungo la SP67, poco oltre Pozzallo. L’imbocco è proprio a bordo strada, un po’ nascosto e si sale a piedi poiché è stretto e dissestato, con grosse buche (sono comunque poche decine di metri). Camper quindi parcheggiato a bordo strada, qualche secondo e sono praticamente in cima a questa piccola scogliera di arenaria, che scopre un’acqua dalle mille sfumature. Sentierini sabbiosi in mezzo ad arbusti aridi mi accompagnano per un centinaio di metri mentre ammiro l’incontro di cielo e mare in una linea sottile all’orizzonte, e meno male che il sole illumina prepotentemente questo ocra splendido: mi ricorda quasi l’Algarve.


 Ci fermiamo poco più avanti a Punta Castellazzo per un pranzetto vista mare e due foto al promontorio (che è sbarrato da una recinzione del vicino b&b, quindi si passa dalla spiaggia per risalire lo scoglio di arenaria). Nel frattempo, peccato, si annuvola, ed il pesante grigio spegne il colore dell’acqua cristallina.
Ci fermiamo poco più avanti a Punta Castellazzo per un pranzetto vista mare e due foto al promontorio (che è sbarrato da una recinzione del vicino b&b, quindi si passa dalla spiaggia per risalire lo scoglio di arenaria). Nel frattempo, peccato, si annuvola, ed il pesante grigio spegne il colore dell’acqua cristallina. La tappa seguente è l’Isola delle Correnti, il punto più a sud della Sicilia, dove Mare Ionio e Mare Mediterraneo si incontrano. Parcheggiamo a lato di un minibar ambulante, sul belvedere che però di fatto non belvede nulla: la cosa migliore è togliere l’infradito e passeggiare sulla spiaggia un centinaio di metri fino al monumento con il piccolo Cristo Redentore, alla cui base una targa commemora il punto come il più a sud della Sicilia. Molto emblematica anche la stessa base su cui il Cristo poggia, che da un lato porta la targa in marmo con scritto “Mar Ionio” e dall’altro la targa con scritto “Mar Mediterraneo”.
La tappa seguente è l’Isola delle Correnti, il punto più a sud della Sicilia, dove Mare Ionio e Mare Mediterraneo si incontrano. Parcheggiamo a lato di un minibar ambulante, sul belvedere che però di fatto non belvede nulla: la cosa migliore è togliere l’infradito e passeggiare sulla spiaggia un centinaio di metri fino al monumento con il piccolo Cristo Redentore, alla cui base una targa commemora il punto come il più a sud della Sicilia. Molto emblematica anche la stessa base su cui il Cristo poggia, che da un lato porta la targa in marmo con scritto “Mar Ionio” e dall’altro la targa con scritto “Mar Mediterraneo”. 





 Questo bellissimo borgo in cui oggi vivono circa 350 anime è stato reso famoso per la prima volta nel 1993 da Gabriele Salvatores per essere stato la location del suo film “Sud”.
Questo bellissimo borgo in cui oggi vivono circa 350 anime è stato reso famoso per la prima volta nel 1993 da Gabriele Salvatores per essere stato la location del suo film “Sud”.
 Oggi, grazie soprattutto al web e ad Instagram è una meta popolare ed ambita, forse per il suo fascino che sa di mare ed aria salmastra, forse per quei ristorantini in pietra che si affacciano sulla grossa piazza, decorati con piante grasse e vasetti in ceramica dipinta, o per le caratteristiche sedie impagliate in legno dipinte di azzurro, bianco e turchese, forse per le anfore decorate davanti alle casette.
Oggi, grazie soprattutto al web e ad Instagram è una meta popolare ed ambita, forse per il suo fascino che sa di mare ed aria salmastra, forse per quei ristorantini in pietra che si affacciano sulla grossa piazza, decorati con piante grasse e vasetti in ceramica dipinta, o per le caratteristiche sedie impagliate in legno dipinte di azzurro, bianco e turchese, forse per le anfore decorate davanti alle casette.
 L’intero borgo è pedonale, noi parcheggiamo a 400 metri dal cuore marinaro presso un’area che ci costa 6,00 € fino a domani mattina. Pur essendo molto piccolo, è piacevole girare per tutte le viuzze senza alcun disturbo di auto.
L’intero borgo è pedonale, noi parcheggiamo a 400 metri dal cuore marinaro presso un’area che ci costa 6,00 € fino a domani mattina. Pur essendo molto piccolo, è piacevole girare per tutte le viuzze senza alcun disturbo di auto.

Dopo cena ancora due passi fuori per qualche scatto in notturna, ma l’aria è decisamente freddissima, quindi rientriamo abbastanza in fretta.
Martedì 20 ottobre – km 109293
da Marzamemi a Siracusa (84 km)
 Stamattina ore 8:30, puntualissimi, lasciamo il comodo parcheggio di Marzamemi per la Riserva di Vendicari, a circa 15 chilometri di distanza, dove abbiamo in programma di dare un’occhiata all’antica Tonnara. La stradina per l’ingresso alla riserva, lasciata la principale, è un po’ stretta e ricca di fogliame (con immensa gioia del babbo, che protesta perché i rami degli ulivi rischiano di graffiare il camper).
Il parcheggio è deserto e a pagamento, l’omino ci dice 3,50 € per le macchine e 7,00 € per i camper, che ci sembra un furto (soprattutto perché i miei non scendono nemmeno). Decidiamo quindi di lasciare il pick-up con cellula di Vito e Luciana al parcheggio, mentre i miei tornano indietro al bivio e ci aspettano, e noi tre ci incamminiamo. Alcune centinaia di metri e siamo alla biglietteria della Riserva. Prezzo d’ingresso, 3,50 €. Ancora un chilometro di bella stradella pavimentata e passerella in legno che conduce al primo arenile: la Spiaggia di Vendicari. Presenta un lunghissimo litorale sabbioso, dal fondale basso che degrada dolcemente verso il largo.
Stamattina ore 8:30, puntualissimi, lasciamo il comodo parcheggio di Marzamemi per la Riserva di Vendicari, a circa 15 chilometri di distanza, dove abbiamo in programma di dare un’occhiata all’antica Tonnara. La stradina per l’ingresso alla riserva, lasciata la principale, è un po’ stretta e ricca di fogliame (con immensa gioia del babbo, che protesta perché i rami degli ulivi rischiano di graffiare il camper).
Il parcheggio è deserto e a pagamento, l’omino ci dice 3,50 € per le macchine e 7,00 € per i camper, che ci sembra un furto (soprattutto perché i miei non scendono nemmeno). Decidiamo quindi di lasciare il pick-up con cellula di Vito e Luciana al parcheggio, mentre i miei tornano indietro al bivio e ci aspettano, e noi tre ci incamminiamo. Alcune centinaia di metri e siamo alla biglietteria della Riserva. Prezzo d’ingresso, 3,50 €. Ancora un chilometro di bella stradella pavimentata e passerella in legno che conduce al primo arenile: la Spiaggia di Vendicari. Presenta un lunghissimo litorale sabbioso, dal fondale basso che degrada dolcemente verso il largo.


Subito di fronte troviamo l’isolotto di Vendicari e spostando lo sguardo ecco i resti dell’Antica Tonnara, affascinante sito di archeologia industriale che domina l’intero litorale, contornato dalle antiche case dei pescatori.


 La zona della riserva di Vendicari fin dall’epoca tardo antica, fu centro portuale per le comunità rurali della zona fino, presumibilmente, alla fine del Medioevo e anche oltre. Questo è il motivo per cui, con tutta probabilità, si rese necessaria la costruzione della Torre Sveva (nel Quattrocento), poco più avanti, che si pensa sia stata fatta costruire da Pietro d’Aragona per proteggere i magazzini in cui venivano stoccate le derrate alimentari. All’interno della riserva ci sono alcuni pantanetti e diversi casottini per birdwatching, nonché calette, ma noi ci accontentiamo del minimo indispensabile e torniamo al camper.
La zona della riserva di Vendicari fin dall’epoca tardo antica, fu centro portuale per le comunità rurali della zona fino, presumibilmente, alla fine del Medioevo e anche oltre. Questo è il motivo per cui, con tutta probabilità, si rese necessaria la costruzione della Torre Sveva (nel Quattrocento), poco più avanti, che si pensa sia stata fatta costruire da Pietro d’Aragona per proteggere i magazzini in cui venivano stoccate le derrate alimentari. All’interno della riserva ci sono alcuni pantanetti e diversi casottini per birdwatching, nonché calette, ma noi ci accontentiamo del minimo indispensabile e torniamo al camper.Prima di mezzogiorno siamo a Noto, capitale del barocco. Parcheggiamo presso un’ampia area di sosta gratuita in Via Tommaso Fazello, praticamente una sorta di circonvallazione attorno al nucleo storico. Poche centinaia di metri e, dopo aver superato Palazzo Castelluccio, siamo praticamente in centro, seguendo Via Cavour. La prima cosa degna di nota che vediamo, oltre le transenne per un film in costume che stanno girando all’interno dell’edificio, è la bella piazza su cui si affacciano i maggiori capolavori barocchi.



 Di fronte, la Cattedrale di Noto, intitolata a San Nicolò, che rappresenta il più importante luogo di culto della città. La costruzione iniziò nel 1693, ma a causa dei vari terremoti che si susseguirono nell’arco dei secoli subì danni e rifacimenti. La struttura attuale è in parte frutto degli ultimi lavori: durante il terremo di Santa Lucia del 1990, i pilastri a supporto della cupola della chiesa subirono dei danni, e nel 1996 l’ennesimo terremoto portò al rovinoso crollo della cupola (già danneggiata da infiltrazioni d’acqua), della navata maggiore e di quella orientale. Ci sono voluti altri dieci anni perché la chiesa fosse riaperta, ma gli interni non sono più quelli di un tempo: le pareti sono bianche ed asettiche, pochissimi affreschi (quelli restaurati). Inizio a pensare che dopo il Novecento nessuno sia stato in grado di costruire un luogo di culto decente, o di ristrutturarne uno secondo i criteri stilistici ed architettonici che hanno riempito secoli di storia.
Di fronte, la Cattedrale di Noto, intitolata a San Nicolò, che rappresenta il più importante luogo di culto della città. La costruzione iniziò nel 1693, ma a causa dei vari terremoti che si susseguirono nell’arco dei secoli subì danni e rifacimenti. La struttura attuale è in parte frutto degli ultimi lavori: durante il terremo di Santa Lucia del 1990, i pilastri a supporto della cupola della chiesa subirono dei danni, e nel 1996 l’ennesimo terremoto portò al rovinoso crollo della cupola (già danneggiata da infiltrazioni d’acqua), della navata maggiore e di quella orientale. Ci sono voluti altri dieci anni perché la chiesa fosse riaperta, ma gli interni non sono più quelli di un tempo: le pareti sono bianche ed asettiche, pochissimi affreschi (quelli restaurati). Inizio a pensare che dopo il Novecento nessuno sia stato in grado di costruire un luogo di culto decente, o di ristrutturarne uno secondo i criteri stilistici ed architettonici che hanno riempito secoli di storia. Ci fermiamo per pranzo in una friggitoria poco distante per assaporare un gustoso "cuoppo", un cartoccio a forma di cono che si riempie con ogni sorta di fritto. Benché il cuoppo sia di origine napoletana, oramai è largamente diffuso un po' ovunque e rappresenta il classico cibo da strada che si può consumare in compagnia o da soli, magari in sostituzione del pranzo e della cena, ma va bene anche come aperitivo. Anche se non oso immaginare chi possa avere coraggio di farci l'aperitivo e poi andare a mangiare! Voglio dire, il nostro cuoppo di verdure fritte già da solo sazierebbe due persone, ma non contenti ci abbiniamo un pezzettino di ricotta fritta, pesce fritto, patatine fritte, e auguri fegato. Altro che aperitivo!
Ci fermiamo per pranzo in una friggitoria poco distante per assaporare un gustoso "cuoppo", un cartoccio a forma di cono che si riempie con ogni sorta di fritto. Benché il cuoppo sia di origine napoletana, oramai è largamente diffuso un po' ovunque e rappresenta il classico cibo da strada che si può consumare in compagnia o da soli, magari in sostituzione del pranzo e della cena, ma va bene anche come aperitivo. Anche se non oso immaginare chi possa avere coraggio di farci l'aperitivo e poi andare a mangiare! Voglio dire, il nostro cuoppo di verdure fritte già da solo sazierebbe due persone, ma non contenti ci abbiniamo un pezzettino di ricotta fritta, pesce fritto, patatine fritte, e auguri fegato. Altro che aperitivo!
Riprendiamo poi a camminare sperando di digerire. Lungo Corso Vittorio Emanuele troviamo anche la Chiesa di San Francesco d’Assisi ed una piazzetta con una graziosa fontana. Il sole illumina gli edifici in pietra mentre raggiungiamo la Porta Ferdinandea (o Porta Reale), simbolo dell’ingresso alla città ed inaugurata nel 1841, in occasione della venuta di Ferdinando II di Borbone, sovrano dell’allora Regno delle Due Sicilie.

 Ultima tappa, di fronte al Teatro Tina di Lorenzo, la bellissima Chiesa di San Domenico, unanimemente considerata la chiesa più rappresentativa del barocco netino e tra i più significativi patrimoni tardo-barocchi della Sicilia sud-orientale. Edificata all’inizio del Settecento, si affaccia su Piazza XVI Maggio, una piazzetta adornata dai giardini di Villetta Ercole. Peccato che sia chiusa e quindi impossibile da visitare!
Ultima tappa, di fronte al Teatro Tina di Lorenzo, la bellissima Chiesa di San Domenico, unanimemente considerata la chiesa più rappresentativa del barocco netino e tra i più significativi patrimoni tardo-barocchi della Sicilia sud-orientale. Edificata all’inizio del Settecento, si affaccia su Piazza XVI Maggio, una piazzetta adornata dai giardini di Villetta Ercole. Peccato che sia chiusa e quindi impossibile da visitare!Torniamo al camper, ci spostiamo poco dopo le 16 e facciamo una piccola capatina ad Avola e anzi: troviamo anche un ampio parcheggio proprio di fronte alla tonnara diroccata, di fronte al molo. Il tempo di beccarci qualche minuto di sole in mezzo alle nuvole e di rumore del mare, e ripartiamo. Con il sole già basso sull’orizzonte arriviamo a Siracusa. Mentre cerchiamo un parcheggio tra le nostre alternative, valutiamo HippoCamper, dove però il gestore si pone in modo estremamente scortese, come se ci stesse facendo un favore, senza contare che ogni elettricità, navetta ma soprattutto docce hanno un costo aggiuntivo (e non è che il costo della sosta sia regalato, considerando anche gli spazi!). Quasi per caso telefoniamo al signor Claudio, dell’area sosta Claud Car, che per noi che siamo in 3 costa 20,00 € a notte. Docce calde ed elettricità incluse nel prezzo, più eventuale servizio navetta a/r per il centro a 2,50 € a persona. Arriviamo e ci conosciamo di persona. E’ un tipo gentile e disponibile, molto “imprenditore”, che si dedica alla sua area sosta con cuore ed idee. Decidiamo, quindi, di restare un paio di giorni almeno, e ci posizioniamo sotto una verandona con alcuni posti camper. Mai scelta fu più azzeccata: siamo vicini ai bagni e, soprattutto, il camper resterà fresco per tutto il tempo!
Mercoledì 21 ottobre – km 109377
Siracusa e Isola di Ortigia (by night)
 Stamattina, come da programma, il signor Claudio ci accompagna con la navetta fino alla Neapolis, il grosso sito archeologico che contiene i più importanti resti della Siracusa greca ed ha valso alla città il titolo di patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO. Il parco può essere visitato autonomamente o usufruendo di una guida, ed il biglietto costa 10,00 € senza riduzioni. Entriamo seguendo le frecce, e la prima cosa che vediamo sulla sinistra è l’Ara di Ierone II, visitabile solo all'esterno. Si tratta di una imponente piattaforma lunga quasi 200 m con delle scale di accesso: è un altare dedicato agli dei, voluto dal re siracusano Ierone II nel 200 a.C da dedicare a Zeus Eleutherios, "liberatore", principale divinità del pantheon greco. La leggenda vuole che su questo altare avvenissero vere e proprie ecatombi che vedevano il sacrificio di ben 450 animali in una volta sola.
Stamattina, come da programma, il signor Claudio ci accompagna con la navetta fino alla Neapolis, il grosso sito archeologico che contiene i più importanti resti della Siracusa greca ed ha valso alla città il titolo di patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO. Il parco può essere visitato autonomamente o usufruendo di una guida, ed il biglietto costa 10,00 € senza riduzioni. Entriamo seguendo le frecce, e la prima cosa che vediamo sulla sinistra è l’Ara di Ierone II, visitabile solo all'esterno. Si tratta di una imponente piattaforma lunga quasi 200 m con delle scale di accesso: è un altare dedicato agli dei, voluto dal re siracusano Ierone II nel 200 a.C da dedicare a Zeus Eleutherios, "liberatore", principale divinità del pantheon greco. La leggenda vuole che su questo altare avvenissero vere e proprie ecatombi che vedevano il sacrificio di ben 450 animali in una volta sola.
 Scendendo da una breve scalinata si entra nel meraviglioso giardino che è la Latomia del Paradiso, una grande vallata artificiale, una cava di pietra scavata a "forza di braccia" nel corso dei secoli e che è servita anche da prigione per migliaia di schiavi. Oggi invece è un angolo incantevole con una lussureggiante vegetazione di piante mediterranee ed esotiche (palme, ficus). Lungo i fianchi della vallata sono scavate varie grotte anch'esse artificiali. Tra queste la Grotta dei Cordari, che prende il nome dagli antichi artigiani che fino al secolo scorso vi si erano insediati.
La più famosa è invece l’Orecchio di Dionisio, una cavità artificiale alta circa 30 m e profonda 40 m che esteriormente ricorda la forma di un orecchio. La particolarità di questa grotta è che amplifica enormemente la voce e veniva addirittura usata come cassa di risonanza durante gli spettacoli del vicino teatro. La leggenda vuole che il tiranno Dionisio facesse rinchiudere qui dentro i propri prigionieri, ben consapevole di questa particolarità acustica della grotta. Da un piccolo foro, poteva così ascoltare senza essere visto, i sussurri dei prigionieri. Se qualcuno diceva qualcosa di sconveniente o complottava, egli lo veniva a scoprire e lo faceva uccidere.
Scendendo da una breve scalinata si entra nel meraviglioso giardino che è la Latomia del Paradiso, una grande vallata artificiale, una cava di pietra scavata a "forza di braccia" nel corso dei secoli e che è servita anche da prigione per migliaia di schiavi. Oggi invece è un angolo incantevole con una lussureggiante vegetazione di piante mediterranee ed esotiche (palme, ficus). Lungo i fianchi della vallata sono scavate varie grotte anch'esse artificiali. Tra queste la Grotta dei Cordari, che prende il nome dagli antichi artigiani che fino al secolo scorso vi si erano insediati.
La più famosa è invece l’Orecchio di Dionisio, una cavità artificiale alta circa 30 m e profonda 40 m che esteriormente ricorda la forma di un orecchio. La particolarità di questa grotta è che amplifica enormemente la voce e veniva addirittura usata come cassa di risonanza durante gli spettacoli del vicino teatro. La leggenda vuole che il tiranno Dionisio facesse rinchiudere qui dentro i propri prigionieri, ben consapevole di questa particolarità acustica della grotta. Da un piccolo foro, poteva così ascoltare senza essere visto, i sussurri dei prigionieri. Se qualcuno diceva qualcosa di sconveniente o complottava, egli lo veniva a scoprire e lo faceva uccidere.

 L’ultimo monumento che si incontra è anche il più "recente", è l’Anfiteatro Romano, fiancheggiato da una lunga sequenza di sarcofagi di pietra. Essi provengono in realtà dall'area di Megara Iblea ma vengono preservati qui per ragioni di tutela. Dell'anfiteatro romano, purtroppo, non rimane molto in piedi. Le spoliazioni medievali hanno di molto ridotto quello che era uno dei maggiori anfiteatri d’Italia.
Usciamo dal sito e raggiungiamo il Santuario della Madonna delle Lacrime, una struttura estremamente moderna (orripilante nella sua modernità) e la sua forma è oggetto di varie interpretazioni: gli architetti si proponevano di realizzare strutturalmente il concetto ed il senso di elevazione dell’umanità verso Dio. Altri significati attribuiti alla sua forma sono quelli di: faro, identificabile con Maria che conduce verso il porto che è Gesù; tenda dentro la quale la Madre accoglie i suoi figli per condurli al Padre; lacrima che scende dal cielo. Tra l’altro, la costruzione è iniziata alla fine degli anni Ottanta ed è stata inaugurata solo nel 1994 (dall’allora Papa Giovanni Paolo II).
L’ultimo monumento che si incontra è anche il più "recente", è l’Anfiteatro Romano, fiancheggiato da una lunga sequenza di sarcofagi di pietra. Essi provengono in realtà dall'area di Megara Iblea ma vengono preservati qui per ragioni di tutela. Dell'anfiteatro romano, purtroppo, non rimane molto in piedi. Le spoliazioni medievali hanno di molto ridotto quello che era uno dei maggiori anfiteatri d’Italia.
Usciamo dal sito e raggiungiamo il Santuario della Madonna delle Lacrime, una struttura estremamente moderna (orripilante nella sua modernità) e la sua forma è oggetto di varie interpretazioni: gli architetti si proponevano di realizzare strutturalmente il concetto ed il senso di elevazione dell’umanità verso Dio. Altri significati attribuiti alla sua forma sono quelli di: faro, identificabile con Maria che conduce verso il porto che è Gesù; tenda dentro la quale la Madre accoglie i suoi figli per condurli al Padre; lacrima che scende dal cielo. Tra l’altro, la costruzione è iniziata alla fine degli anni Ottanta ed è stata inaugurata solo nel 1994 (dall’allora Papa Giovanni Paolo II).  Mica i miei si staranno invecchiando?!
Mica i miei si staranno invecchiando?!Verso le 18 usciamo di nuovo per un tour all’Isola di Ortigia by night, che visiteremo poi meglio domani in giornata. Arriviamo con il tramonto, che tinge il cielo di rosa mentre si appoggia sull’acqua del porticciolo, e pian piano si fa buio. Si accendono le luci dei ristorantini che mantengono un tono soffuso dentro le viuzze, mentre arriviamo davanti alla Fontana di Diana e, poco più avanti, alla meravigliosa Piazza Duomo, ampia e circondata da edifici barocchi che si specchiano sulla pavimentazione di marmo.

 Ovviamente, in questo tripudio settecentesco, non passa in osservata la Cattedrale Metropolitana della Natività di Maria Santissima, ovvero (brevemente!) l’imponente Duomo.
Ovviamente, in questo tripudio settecentesco, non passa in osservata la Cattedrale Metropolitana della Natività di Maria Santissima, ovvero (brevemente!) l’imponente Duomo.  Quest’isoletta di appena 1,5 chilometri di lunghezza merita senza dubbio una visita, sia di notte che di giorno. I vicoli illuminati e le pavimentazioin la rendono magica, ma la cosa più spettacolare dopo la piazza del Duomo è di certo la Fontana di Diana, che al nostro ritorno (dopo una veloce pizzata tutti insieme da Zsà in Via Roma), la troviamo anche illuminata di verde ed azzurro: una vera meraviglia!
Rientriamo alla base che sono già passate le 22.
Quest’isoletta di appena 1,5 chilometri di lunghezza merita senza dubbio una visita, sia di notte che di giorno. I vicoli illuminati e le pavimentazioin la rendono magica, ma la cosa più spettacolare dopo la piazza del Duomo è di certo la Fontana di Diana, che al nostro ritorno (dopo una veloce pizzata tutti insieme da Zsà in Via Roma), la troviamo anche illuminata di verde ed azzurro: una vera meraviglia!
Rientriamo alla base che sono già passate le 22.Tra scaricare le foto, pappa a Mercurio e due chiacchiere, mezzanotte arriva fin troppo in fretta!
Giovedì 22 ottobre – km 109377
da Siracusa a Catania (84 km)
Oggi torniamo all’Isola di Ortigia per una nuova visita con la luce del giorno. Sicuramente di sera ha il suo fascino, e c’è anche meno gente, ma con una bella giornata soleggiata del genere è bellissimo costeggiare il mare.

 Passiamo davanti al Forte Vigliena e raggiungiamo il Castello Maniace, protesa sul peduncolo roccioso che chiude l’isolotto di Ortigia, volgendo le spalle alla Fonte Aretusa. L’edificio è fra i più importanti monumenti del periodo svevo e sorge su un luogo dove la tradizione narra di precedenti fortificazioni; i recenti scavi, tuttavia, non hanno portato alla luce alcuna traccia del maniero a cui il condottiero bizantino Giorgio Maniace ha dato il nome. Federico II, uomo intelligentissimo, che sapeva costruire i castelli nel punto giusto, sapeva che la difesa di Siracusa era garantita da un lato dal mare e dall’altro da un castello ancora efficiente, posto sulla terraferma, all’imbocco dell’istmo per Ortigia. Per tutto il XIV Secolo, il castello non fu adibito a scopi militari ma veniva impiegato come luogo di contenzione, poi Carlo V intraprese un programma di ampio respiro di consolidamento delle fortificazioni esistenti e di edificazioni di nuovi baluardi.
Passiamo davanti al Forte Vigliena e raggiungiamo il Castello Maniace, protesa sul peduncolo roccioso che chiude l’isolotto di Ortigia, volgendo le spalle alla Fonte Aretusa. L’edificio è fra i più importanti monumenti del periodo svevo e sorge su un luogo dove la tradizione narra di precedenti fortificazioni; i recenti scavi, tuttavia, non hanno portato alla luce alcuna traccia del maniero a cui il condottiero bizantino Giorgio Maniace ha dato il nome. Federico II, uomo intelligentissimo, che sapeva costruire i castelli nel punto giusto, sapeva che la difesa di Siracusa era garantita da un lato dal mare e dall’altro da un castello ancora efficiente, posto sulla terraferma, all’imbocco dell’istmo per Ortigia. Per tutto il XIV Secolo, il castello non fu adibito a scopi militari ma veniva impiegato come luogo di contenzione, poi Carlo V intraprese un programma di ampio respiro di consolidamento delle fortificazioni esistenti e di edificazioni di nuovi baluardi.
 In tale articolato sistema difensivo il castello Maniace doveva diventare il punto di forza: non più in una visione decentrata dalla città, ma punta di diamante protesa sul mare. Si giunge al Castello attraverso un ponte di pietra che sostituisce l’antico ponte levatoio posto su di un fossato di acqua di mare a difesa tutto intorno al Castello. E’ un castello a pianta quadrata, chiuso agli angoli da quattro torrioni cilindrici, e all’interno c’è un’unica sala scandita da colonne con cinque campate per lato.
Si tratta una sala “ipostila” straordinariamente suggestiva, in cui filtra la luce da 15 finestre sulle pareti e da una grande "finestra a mare" sul lato ovest, oltre che dall'atrio centrale aperto a giorno.
In tale articolato sistema difensivo il castello Maniace doveva diventare il punto di forza: non più in una visione decentrata dalla città, ma punta di diamante protesa sul mare. Si giunge al Castello attraverso un ponte di pietra che sostituisce l’antico ponte levatoio posto su di un fossato di acqua di mare a difesa tutto intorno al Castello. E’ un castello a pianta quadrata, chiuso agli angoli da quattro torrioni cilindrici, e all’interno c’è un’unica sala scandita da colonne con cinque campate per lato.
Si tratta una sala “ipostila” straordinariamente suggestiva, in cui filtra la luce da 15 finestre sulle pareti e da una grande "finestra a mare" sul lato ovest, oltre che dall'atrio centrale aperto a giorno.


 Anche la terrazza, circondata da un muro alto oltre 1,60 metri, con uno spazio aperto centrale da cui si vede il piano terra e la sua serie di archi e finestroni a mare, è molto particolare. Nel complesso vale i 4,00 € del biglietto.
Anche la terrazza, circondata da un muro alto oltre 1,60 metri, con uno spazio aperto centrale da cui si vede il piano terra e la sua serie di archi e finestroni a mare, è molto particolare. Nel complesso vale i 4,00 € del biglietto.Ripartiamo, passiamo davanti alla bella Fonte Aretusa e poi nei vicoli fino a tornare davanti alla signora Cattedrale, finalmente illuminata a giorno ed ammirabile in tutto il suo splendore. La facciata rappresenta una lavorazione molto complessa in quanto ricca di decorazioni e per questo considerata l'espressione barocca più alta che vi sia nell'intera Siracusa. I lavori vennero in realtà completati in due periodi diversi, per questo presenta due stili ornamentali: il barocco dei primi del Settecento ed il rococò, al quale il tardo-barocco lasciò spazio dalla seconda metà del secolo (periodo di fine dei lavori). Anche qui, con un biglietto di 2,00 € è possibile visitarne l’interno, che personalmente trovo molto armonico. Le sembianze del tempio greco sono altamente visibili e riconoscibili (varcato il portone centrale dell'atrio si possono anche ammirare due grandi colonne doriche), infatti il Duomo di Siracusa a differenza di molte altre eleganti chiese e cattedrali non mostra colonne lisce o fregi articolati: la sua navata è stata ottenuta aprendo dei varchi nelle spesse mura dell'antica cella del tempio greco, dunque li risultato che oggi vediamo è frutto di una struttura che sta lì da millenni ed è questo il motivo della sua austerità e del suo singolare aspetto.
 L'interno non è stato modificato e le sembianze che mostra sono ancora quelle dell'originaria basilica di epoca normanna, e anche i restauri del primo dopoguerra sono stati effettuati rispettando senza alterare l’originaria forma medievale. Il soffitto della navata invece risale al Cinquecento ed è composto da robuste tavole lignee. Nel restauro del 1645 vi vennero aggiunti gli stemmi delle famiglie nobili siracusane.
L'interno non è stato modificato e le sembianze che mostra sono ancora quelle dell'originaria basilica di epoca normanna, e anche i restauri del primo dopoguerra sono stati effettuati rispettando senza alterare l’originaria forma medievale. Il soffitto della navata invece risale al Cinquecento ed è composto da robuste tavole lignee. Nel restauro del 1645 vi vennero aggiunti gli stemmi delle famiglie nobili siracusane. 




 Un’oretta e mezza e torniamo al porticciolo, per poi riprendere la navetta guidata da Claudio dopo pochi minuti. Completate le operazioni di carico/scarico, ripartiamo in direzione Catania, dove ci aspetta Paolo (un camperista conosciuto dal babbo in un gruppo di viaggi in camper), che vive in città e si è premurato di procurare l’olio nuovo per i nostri compagni di viaggio, e di trovare un posto sicuro per la notte per i nostri camper. Ci incontriamo in Piazza Dante Alighieri e ci fa strada in motorino, dopo che ci siamo persi per venti minuti nelle vie trafficate del centro. Tra l’altro, in Sicilia hanno una guida piuttosto… “creativa”, e non è sempre facile stare al passo, senza contare i vicoli minuscoli in cui il navigatore ci porta. Arriviamo dunque al parcheggio, sempre scortati: un incrocio tra un rimessaggio e una bidonville, ma almeno è custodito. Paolo si giustifica dicendo: “siccome ultimamente hanno rubato un paio di camper, ho preferito suggerirvi un posto tranquillo perché supervisionato anche di notte”… ottimo pensiero, peccato dover pagare 15,00 € per uno dei posti più orribili in tanti anni di onorati viaggi in camper!
Un’oretta e mezza e torniamo al porticciolo, per poi riprendere la navetta guidata da Claudio dopo pochi minuti. Completate le operazioni di carico/scarico, ripartiamo in direzione Catania, dove ci aspetta Paolo (un camperista conosciuto dal babbo in un gruppo di viaggi in camper), che vive in città e si è premurato di procurare l’olio nuovo per i nostri compagni di viaggio, e di trovare un posto sicuro per la notte per i nostri camper. Ci incontriamo in Piazza Dante Alighieri e ci fa strada in motorino, dopo che ci siamo persi per venti minuti nelle vie trafficate del centro. Tra l’altro, in Sicilia hanno una guida piuttosto… “creativa”, e non è sempre facile stare al passo, senza contare i vicoli minuscoli in cui il navigatore ci porta. Arriviamo dunque al parcheggio, sempre scortati: un incrocio tra un rimessaggio e una bidonville, ma almeno è custodito. Paolo si giustifica dicendo: “siccome ultimamente hanno rubato un paio di camper, ho preferito suggerirvi un posto tranquillo perché supervisionato anche di notte”… ottimo pensiero, peccato dover pagare 15,00 € per uno dei posti più orribili in tanti anni di onorati viaggi in camper!Ci pare di capire che questa città sia incasinata.
Rassegnati al fatto che non sia una candid camera, ce ne restiamo mesti in camper.
Meno male che la fiction del giovedì ci tira su la serata.
Venerdì 23 ottobre – km 109442
da Catania al Rifugio Sapienza (65 km)
 Stamattina alle 8:30 Paolo e consorte arrivano all’orribile parcheggio dove abbiamo dormito e ci prelevano per una colazione da Pellegrino, nota gelateria pasticceria di Catania, dove finalmente facciamo una colazione originale siciliana con granita e brioche con “tuppo” ancora calda. Ci spostiamo poi in Piazza Vincenzo Bellini con l’omonimo teatro, molto bello, in pietra rossa. La facciata in stile neobarocco si ispira al classico sansoviniano della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia. Qualche centinaio di metri più avanti, approdiamo in Piazza Duomo, riconoscibile per l’obelisco con l’elefante simbolo della città proprio al centro.
Stamattina alle 8:30 Paolo e consorte arrivano all’orribile parcheggio dove abbiamo dormito e ci prelevano per una colazione da Pellegrino, nota gelateria pasticceria di Catania, dove finalmente facciamo una colazione originale siciliana con granita e brioche con “tuppo” ancora calda. Ci spostiamo poi in Piazza Vincenzo Bellini con l’omonimo teatro, molto bello, in pietra rossa. La facciata in stile neobarocco si ispira al classico sansoviniano della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia. Qualche centinaio di metri più avanti, approdiamo in Piazza Duomo, riconoscibile per l’obelisco con l’elefante simbolo della città proprio al centro. Il sontuoso Duomo di Sant’Agata, il principale luogo di culto della città Catania, si lascia baciare da un sole tiepido, mentre un artista di strada suona l’hang drum (quello strumento dalle sonorità soft composto sa due semisfere appiattite che gli danno la tipica forma a UFO). Subito dietro la piazza, la Fontana dell’Amenano, realizzata a metà Ottocento, che prende il nome dal fiume che scorre sotto Catania. E’ chiamata anche “fontana del velo” proprio perché l’acqua sembra scorrere come dei veli giù dal marmo bianco nel fiume sottostante. Qualche minuto al Mercato del Pesce, per immergerci nella colorata e vivace atmosfera dei venditori ambulanti, e alle 11:30 abbiamo già prenotato un tour con il minibus turistico della linea CityTour.
Il sontuoso Duomo di Sant’Agata, il principale luogo di culto della città Catania, si lascia baciare da un sole tiepido, mentre un artista di strada suona l’hang drum (quello strumento dalle sonorità soft composto sa due semisfere appiattite che gli danno la tipica forma a UFO). Subito dietro la piazza, la Fontana dell’Amenano, realizzata a metà Ottocento, che prende il nome dal fiume che scorre sotto Catania. E’ chiamata anche “fontana del velo” proprio perché l’acqua sembra scorrere come dei veli giù dal marmo bianco nel fiume sottostante. Qualche minuto al Mercato del Pesce, per immergerci nella colorata e vivace atmosfera dei venditori ambulanti, e alle 11:30 abbiamo già prenotato un tour con il minibus turistico della linea CityTour.
 Normalmente non ne approfittiamo mai, ma oggi ci attaccano la pezza in quattro o cinque nel giro di pochi minuti, tutta questa gente che cerca di rifilarci escursioni e visite guidate ci prende per stanchezza, e complici Paolo e consorte che tirano sul prezzo, alla fine strappiamo la visita al costo di 10,00 € anziché 15,00. Il viaggio dura oltre un’ora e mezza, una voce registrata ci illustra i monumenti principali mentre giriamo nel centro storico, poi ci porta fuori Catania fino alla Costa dei Ciclopi, cantata da Omero nella sua Odissea, al cospetto di acqua dalle mille sfumature di cobalto e rocce laviche formate da eruzioni sottomarine preistoriche. Ammirevoli ad Aci Castello il Castello Normanno in cima ad uno sperone roccioso, con una superba vista sulle spiagge nere, e ad Aci Trezza (già famosa per essere l’ambientazione dei Malavoglia di Giovanni Verga) gli otto faraglioni che fuoriescono dalle acque turchesi.
Normalmente non ne approfittiamo mai, ma oggi ci attaccano la pezza in quattro o cinque nel giro di pochi minuti, tutta questa gente che cerca di rifilarci escursioni e visite guidate ci prende per stanchezza, e complici Paolo e consorte che tirano sul prezzo, alla fine strappiamo la visita al costo di 10,00 € anziché 15,00. Il viaggio dura oltre un’ora e mezza, una voce registrata ci illustra i monumenti principali mentre giriamo nel centro storico, poi ci porta fuori Catania fino alla Costa dei Ciclopi, cantata da Omero nella sua Odissea, al cospetto di acqua dalle mille sfumature di cobalto e rocce laviche formate da eruzioni sottomarine preistoriche. Ammirevoli ad Aci Castello il Castello Normanno in cima ad uno sperone roccioso, con una superba vista sulle spiagge nere, e ad Aci Trezza (già famosa per essere l’ambientazione dei Malavoglia di Giovanni Verga) gli otto faraglioni che fuoriescono dalle acque turchesi.
 Narra la leggenda che il gigante Polifemo, dopo essere stato accecato da Ulisse in fuga, cercò di rincorrerlo e fermarlo scagliandogli dietro le cime delle montagne, che si arenarono sulla costa. Nel complesso, il tour non è male, peccato il poco tempo per le foto, che fatte dal bus in movimento non sono proprio il massimo (ci metterò mesi a “pulirle”!). Torniamo in Piazza Duomo, da dove il tour è partito, e ragionando sul da farsi ci dividiamo. Torno rapidamente al camper a controllare e custodire Mercurio (che sta una meraviglia senza di noi!) e poi parto per un tour a modo mio. Recupero la vergara poco lontano, mentre gli altri si ritrovano con Paolo e consorte per un caffè e due chiacchiere in tranquillità. Noi raggiungiamo il Monastero dei Benedettini di San Nicolò all’Arena. Il monastero fu costruito all'inizio del Settecento e dichiarato monumento nazionale con regio decreto del 15 agosto 1869. Nel 2002 viene inserito nell'elenco del patrimonio mondiale dell'UNESCO come "gioiello del tardo-barocco siciliano" facente parte all'itinerario del "tardo-barocco siciliano del Val di Noto". E' uno dei più grandi monasteri d'Europa e un esempio della ricchezza di cui godeva l'ordine benedettino. Ora parte dell'università della città, il monastero ospita due grandiosi chiostri interni e una delle biblioteche più importanti della Sicilia.
Narra la leggenda che il gigante Polifemo, dopo essere stato accecato da Ulisse in fuga, cercò di rincorrerlo e fermarlo scagliandogli dietro le cime delle montagne, che si arenarono sulla costa. Nel complesso, il tour non è male, peccato il poco tempo per le foto, che fatte dal bus in movimento non sono proprio il massimo (ci metterò mesi a “pulirle”!). Torniamo in Piazza Duomo, da dove il tour è partito, e ragionando sul da farsi ci dividiamo. Torno rapidamente al camper a controllare e custodire Mercurio (che sta una meraviglia senza di noi!) e poi parto per un tour a modo mio. Recupero la vergara poco lontano, mentre gli altri si ritrovano con Paolo e consorte per un caffè e due chiacchiere in tranquillità. Noi raggiungiamo il Monastero dei Benedettini di San Nicolò all’Arena. Il monastero fu costruito all'inizio del Settecento e dichiarato monumento nazionale con regio decreto del 15 agosto 1869. Nel 2002 viene inserito nell'elenco del patrimonio mondiale dell'UNESCO come "gioiello del tardo-barocco siciliano" facente parte all'itinerario del "tardo-barocco siciliano del Val di Noto". E' uno dei più grandi monasteri d'Europa e un esempio della ricchezza di cui godeva l'ordine benedettino. Ora parte dell'università della città, il monastero ospita due grandiosi chiostri interni e una delle biblioteche più importanti della Sicilia.



Con il sole che declina lento sull’orizzonte e dietro le colline, tingendo di rosa il fumarello dell’Etna, arriviamo a Nicolosi ed imbocchiamo la strada che si arrampica per una ventina di chilometri fino al Rifugio Sapienza a quota 1927 metri. Le luci tremolanti di Catania e del golfo sono meravigliose, e si estendono fin dove lo sguardo può arrivare. Arrivati finalmente a destinazione, parcheggiamo nell’ampio piazzale di fronte al rifugio, con vista panoramica. Dopo cena, nel freddo pungente amplificato da un bel vento a zaffate ripetute, scendo per alcune foto al golfo illuminato e tento di trovare la Via Lattea, senza grossi risultati a causa dei lampioni che illuminano il parcheggio.
Sabato 24 ottobre – km 109480
dal Rifugio Sapienza a Motta Camastra (60 km)
 Dopo una notte bella fresca, stamattina alle 8:30 siamo operativi come sempre. L’aria è ancora abbastanza fredda, quindi temporeggio un po’. Chiedo informazioni al gabbiotto dove paghiamo il parcheggio giornaliero 6,00 €), poi mi copro bene ed inizio la mia scalata verso “a muntagna”, come viene chiamato l’Etna dai siciliani. Imbocco il sentiero 702 del CAI, quello di rito. Ci sono alcuni temerari che salgono qua e là, mentre la maggior parte va in funivia (o jeep sostitutiva) fino al Rifugio Etna a 2500 metri al costo di 30,00 € (per tre chilometri, onestamente, vado a piedi!). Inizio a togliermi alcuni strati perché appena mi muovo inizio a scaldarmi (parto da quasi 2000 metri di quota, ma l’aria si scalda subito), mi arrampico in salita lungo un accenno di percorso abbastanza ripido, poiché l’alternativa è seguire il battuto dei fuoristrada (decisamente più agevole) e mangiarmi chili di polvere.
Dopo una notte bella fresca, stamattina alle 8:30 siamo operativi come sempre. L’aria è ancora abbastanza fredda, quindi temporeggio un po’. Chiedo informazioni al gabbiotto dove paghiamo il parcheggio giornaliero 6,00 €), poi mi copro bene ed inizio la mia scalata verso “a muntagna”, come viene chiamato l’Etna dai siciliani. Imbocco il sentiero 702 del CAI, quello di rito. Ci sono alcuni temerari che salgono qua e là, mentre la maggior parte va in funivia (o jeep sostitutiva) fino al Rifugio Etna a 2500 metri al costo di 30,00 € (per tre chilometri, onestamente, vado a piedi!). Inizio a togliermi alcuni strati perché appena mi muovo inizio a scaldarmi (parto da quasi 2000 metri di quota, ma l’aria si scalda subito), mi arrampico in salita lungo un accenno di percorso abbastanza ripido, poiché l’alternativa è seguire il battuto dei fuoristrada (decisamente più agevole) e mangiarmi chili di polvere.

 Chiedo info per la salita in jeep, mi rispondono che la jeep/navetta costa 36,00 € a/r (per percorrere un totale di quasi 8 km, tra l’andata fino alla Torre del Filosofo sotto i Crateri Barbagallo e il ritorno). Il tipo è anche molto onesto e mi dice che comunque, volendo, posso andare a piedi perché comunque con la jeep non si arriva più lontano. Il resto della strada oltre il Rifugio della Protezione Civile, è a mio rischio e pericolo in quanto passibile di verbale da parte della finanza. Peraltro, solo per riscendere da dove sono al Rifugio Sapienza in funivia mi costa 20,00 €. Insomma, considerando l’intero ambaradan un furto, decido di mettere in moto i piedi e basta, non mi interessa quanto tempo ci voglia.
Chiedo info per la salita in jeep, mi rispondono che la jeep/navetta costa 36,00 € a/r (per percorrere un totale di quasi 8 km, tra l’andata fino alla Torre del Filosofo sotto i Crateri Barbagallo e il ritorno). Il tipo è anche molto onesto e mi dice che comunque, volendo, posso andare a piedi perché comunque con la jeep non si arriva più lontano. Il resto della strada oltre il Rifugio della Protezione Civile, è a mio rischio e pericolo in quanto passibile di verbale da parte della finanza. Peraltro, solo per riscendere da dove sono al Rifugio Sapienza in funivia mi costa 20,00 €. Insomma, considerando l’intero ambaradan un furto, decido di mettere in moto i piedi e basta, non mi interessa quanto tempo ci voglia. 

 Riscendo verso il Bar Etna (la prima parte è abbastanza semplice da percorrere in discesa), e una volta arrivata, con una fame da lupi, mi lascio tentare da un arancino a punta e uno spritz, vista vallata piena di foschia! Riprendo il cammino ma, mentre all’andata ho seguito pedissequamente l’itinerario, al ritorno con la testa per aria vado a caso, seguendo i tralicci della funivia ed il parcheggio in fondo alla discesa, con le scarpe che scivolano continuamente sulla ghiaietta, sollevando nuvoloni di polvere. Inutile dire che il nero della polvere lavica me la ritrovo, appena arrivata al camper, anche tra le dita dei piedi e fino alle caviglie.
Riscendo verso il Bar Etna (la prima parte è abbastanza semplice da percorrere in discesa), e una volta arrivata, con una fame da lupi, mi lascio tentare da un arancino a punta e uno spritz, vista vallata piena di foschia! Riprendo il cammino ma, mentre all’andata ho seguito pedissequamente l’itinerario, al ritorno con la testa per aria vado a caso, seguendo i tralicci della funivia ed il parcheggio in fondo alla discesa, con le scarpe che scivolano continuamente sulla ghiaietta, sollevando nuvoloni di polvere. Inutile dire che il nero della polvere lavica me la ritrovo, appena arrivata al camper, anche tra le dita dei piedi e fino alle caviglie.Ci lasciamo il rifugio alle spalle intorno alle 15:30, ripercorriamo la SP92 dell’Etna fino a valle, poi gpl, gasolio, Lidl per pane ed entro sera siamo praticamente di fronte all’ingresso principale per le Gole di Alcantara, sul lato opposto della strada, all’Area/azienda Gole dell’Alcantara di Motta Camastra. L’ingresso dell’area è angusto, con rami di alberi lungo il viottolo e, soprattutto, sembra praticamente chiuso. Qualcuno arriva dopo dieci minuti di attese e perplessità, e alla fine riusciamo a sistemarci.
Oggi siamo tutti abbastanza cotti.
Mi sa che iniziamo ad accusare la stanchezza del viaggio.
25 ottobre – km 109540
da Motta Camastra a Giardini Naxos (25 km)
 Stamattina, complice l’ora solare (ieri abbiamo rimesso le lancette indietro di un’ora), ci svegliamo alle 6:30, dopo una nottata un po’ movimentata causa gatto iperattivo. Sono già le 9 (poiché prima è tutto chiuso) quando attraverso la strada per entrare nel Parco botanico delle Gole di Alcantara. Una tappa d’obbligo se si è in zona, irrinunciabile. Le gole sono veri e propri canyon ed attraversano un paesaggio che alterna rocce a vegetazione rigogliosa e selvaggia. Sono strette, lunghissime e altissime: davvero particolari nella forma.
Stamattina, complice l’ora solare (ieri abbiamo rimesso le lancette indietro di un’ora), ci svegliamo alle 6:30, dopo una nottata un po’ movimentata causa gatto iperattivo. Sono già le 9 (poiché prima è tutto chiuso) quando attraverso la strada per entrare nel Parco botanico delle Gole di Alcantara. Una tappa d’obbligo se si è in zona, irrinunciabile. Le gole sono veri e propri canyon ed attraversano un paesaggio che alterna rocce a vegetazione rigogliosa e selvaggia. Sono strette, lunghissime e altissime: davvero particolari nella forma.Gli amanti degli sport e dell’avventura potranno provare diverse attività, come il canyoning, ovvero discese con funi e caschetto, oppure attraversare il parco con il quad o, ancora, il body rafting, un trekking immersi nelle acque del fiume per osservare da vicino le formazioni laviche. Insomma, un piccolo paradiso tutto da scoprire. Io non ho molto tempo, ma vediamo cosa riesco a fare stamattina. Gli itinerari proposti alla biglietteria sono tre, con tre differenti prezzi. Il tour con la navettina all’interno del parco costa 15,00 €, l’ingresso con discesa in ascensore alla spiaggetta d’accesso al canyon e percorso botanico costa 10,00 € e l’ingresso “basic”, per fare un giro autonomo nel fiume e dentro le gole, costa 6,00 €. Io sono già pronta con pantaloncini corti e scarpini da scoglio (consigliatissimi se si vuole camminare nell’acqua!) a prendere l’ascensore e scendere. Arrivata alla spiaggetta, mi trovo davanti il fiume freddo.
 Il fiume che dona il nome alle gole (così chiamato dagli Arabi perché si attraversava mediante un ponte di pietra - al-Qantarah significa appunto «il ponte»), a differenza di quanto si possa pensare, non è stato il responsabile di queste meravigliose formazioni.
Il fiume che dona il nome alle gole (così chiamato dagli Arabi perché si attraversava mediante un ponte di pietra - al-Qantarah significa appunto «il ponte»), a differenza di quanto si possa pensare, non è stato il responsabile di queste meravigliose formazioni. Recupero la truppa poco dopo, torniamo al camper. La gentile signora dell’area di sosta ci lascia raccogliere fichi d’india e melagrane dal suo orto, dopodiché mangiamo qualcosina e partiamo verso Giardini Naxos, dove arriviamo abbastanza presto. Per la precisione siamo nel quartiere di Schisò e ci fermiamo nell’area sosta camper Eden Parking, al costo di 13,00 €, a poche centinaia di metri dal lungomare e dal Castello di Schisò (poco più che un rudere, in effetti, tanto che l'idea iniziale era proprio visitarlo... ma una volta al suo cospetto optiamo invece per tutt'altro!).
Recupero la truppa poco dopo, torniamo al camper. La gentile signora dell’area di sosta ci lascia raccogliere fichi d’india e melagrane dal suo orto, dopodiché mangiamo qualcosina e partiamo verso Giardini Naxos, dove arriviamo abbastanza presto. Per la precisione siamo nel quartiere di Schisò e ci fermiamo nell’area sosta camper Eden Parking, al costo di 13,00 €, a poche centinaia di metri dal lungomare e dal Castello di Schisò (poco più che un rudere, in effetti, tanto che l'idea iniziale era proprio visitarlo... ma una volta al suo cospetto optiamo invece per tutt'altro!).
Lunedì 26 ottobre – km 109575
Taormina e Castelmola
 Stamattina l’aria è fresca, l’app del meteo ci dice che le massime arriveranno a 22°C, quindi mi organizzo l’abbigliamento, considerando che ho deciso di arrivare a piedi a Taormina, mentre i miei e gli altri andranno in bus (la fermata è a trecento metri dall’area sosta camper). I primi due chilometri della mia passeggiata verso la rinomata località siciliana sono in piano, seguendo il grazioso lungomare di Giardini Naxos, con la piazzetta a scacchi e la statua del Sileno, segno del filo che unisce Giardini Naxos alle sue antichissime origini. Il Sileno, secondo la mitologia greca, era una divinità dei boschi e della natura selvaggia: figlio di Pan, aveva aspetto umano con coda e orecchie equine. Era costantemente ubriaco e trascorreva il tempo inseguendo le ninfe dei boschi con atteggiamenti osceni; inventò anche alcuni strumenti musicali e se qualcuno riusciva a catturarlo raccontava storie straordinarie svelando importanti segreti. Nella vecchiaia il Sileno allevò Dioniso, il dio del vino, ed entrò a far parte del suo corteo durante le feste e nelle vendemmie. Altro aspetto bellissimo di questo lungomare è l'acqua, decisamente turchese: un piacere per gli occhi!
Stamattina l’aria è fresca, l’app del meteo ci dice che le massime arriveranno a 22°C, quindi mi organizzo l’abbigliamento, considerando che ho deciso di arrivare a piedi a Taormina, mentre i miei e gli altri andranno in bus (la fermata è a trecento metri dall’area sosta camper). I primi due chilometri della mia passeggiata verso la rinomata località siciliana sono in piano, seguendo il grazioso lungomare di Giardini Naxos, con la piazzetta a scacchi e la statua del Sileno, segno del filo che unisce Giardini Naxos alle sue antichissime origini. Il Sileno, secondo la mitologia greca, era una divinità dei boschi e della natura selvaggia: figlio di Pan, aveva aspetto umano con coda e orecchie equine. Era costantemente ubriaco e trascorreva il tempo inseguendo le ninfe dei boschi con atteggiamenti osceni; inventò anche alcuni strumenti musicali e se qualcuno riusciva a catturarlo raccontava storie straordinarie svelando importanti segreti. Nella vecchiaia il Sileno allevò Dioniso, il dio del vino, ed entrò a far parte del suo corteo durante le feste e nelle vendemmie. Altro aspetto bellissimo di questo lungomare è l'acqua, decisamente turchese: un piacere per gli occhi!
 Peccato che, dalla fine del lungomare in poi, i tre chilometri rimanenti non solo si inerpicano con svariati tornanti (sarebbe il male minore!) ma senza un cencio di marciapiede. Sconsigliatissima. E no, non la rifarei, anche perché ad un tratto durante la salita mi perdo nei meandri dell’ospedale civile! Insomma, alla fine ci metto tantissimo ad arrivare, ma entro trionfante da Porta Catania.
Peccato che, dalla fine del lungomare in poi, i tre chilometri rimanenti non solo si inerpicano con svariati tornanti (sarebbe il male minore!) ma senza un cencio di marciapiede. Sconsigliatissima. E no, non la rifarei, anche perché ad un tratto durante la salita mi perdo nei meandri dell’ospedale civile! Insomma, alla fine ci metto tantissimo ad arrivare, ma entro trionfante da Porta Catania.


 Grazie alla sua incantevole posizione sul mare, alle bellezze paesaggistiche, al vasto patrimonio storico, culturale e archeologico, Taormina è una delle località turistiche più famose di tutta la Sicilia. Questa splendida cittadina siciliana ha sedotto poeti e scrittori, ha attratto viaggiatori illustri, ha accolto celebrità di fama internazionale. I visitatori arrivano da tutto il mondo in questo “lembo di paradiso sulla terra” (come scrisse Goethe, nel suo “Viaggio in Italia”), per vedere il teatro greco-romano, per passeggiare lungo le strade medievali, per ammirare i panorami mozzafiato. Del resto, come affermò lo scrittore francese Guy de Maupassant, a Taormina “si trova tutto ciò che sembra creato in terra per sedurre gli occhi, la mente e la fantasia”.
Grazie alla sua incantevole posizione sul mare, alle bellezze paesaggistiche, al vasto patrimonio storico, culturale e archeologico, Taormina è una delle località turistiche più famose di tutta la Sicilia. Questa splendida cittadina siciliana ha sedotto poeti e scrittori, ha attratto viaggiatori illustri, ha accolto celebrità di fama internazionale. I visitatori arrivano da tutto il mondo in questo “lembo di paradiso sulla terra” (come scrisse Goethe, nel suo “Viaggio in Italia”), per vedere il teatro greco-romano, per passeggiare lungo le strade medievali, per ammirare i panorami mozzafiato. Del resto, come affermò lo scrittore francese Guy de Maupassant, a Taormina “si trova tutto ciò che sembra creato in terra per sedurre gli occhi, la mente e la fantasia”.  La piazza forse più famosa di Taormina è Piazza IX Aprile, che si apre a metà del Corso con la sua suggestiva terrazza panoramica sul mare, una spettacolare vista sul golfo e l’Etna che incanta i turisti. I caffè all’aperto e le costruzioni storiche le fanno da cornice. Sulla piazza si affacciano la chiesa barocca di San Giuseppe (XVII secolo), l’ex Chiesa gotica di Sant’Agostino e la Torre dell’Orologio, il cui arco dà accesso alla città vecchia. Costruita nel XII Secolo, distrutta durante l’invasione francese, la torre fu ricostruita nel 1679 e in quell’occasione fu collocato l’orologio da cui prende il nome.
La piazza forse più famosa di Taormina è Piazza IX Aprile, che si apre a metà del Corso con la sua suggestiva terrazza panoramica sul mare, una spettacolare vista sul golfo e l’Etna che incanta i turisti. I caffè all’aperto e le costruzioni storiche le fanno da cornice. Sulla piazza si affacciano la chiesa barocca di San Giuseppe (XVII secolo), l’ex Chiesa gotica di Sant’Agostino e la Torre dell’Orologio, il cui arco dà accesso alla città vecchia. Costruita nel XII Secolo, distrutta durante l’invasione francese, la torre fu ricostruita nel 1679 e in quell’occasione fu collocato l’orologio da cui prende il nome.Recupero i miei a Porta Messina, decisione last minute è di prendere un bus per arrampicarci fino a Castelmola, borgo di mille anime a 500 metri sul livello del mare, inserito nel circuito dei Borghi più Belli d’Italia. Il bus ci lascia in Piazza Sant’Antonio, con la sua terrazza panoramica sulla costa ionica siciliana, sulle baie del suo litorale e su Taormina.

Poiché il Castello di Mola (o meglio, i ruderi che ne restano) è chiuso e non visitabile, non resta che passeggiare e perdersi nei vicoli stretti in cui si assapora ancora oggi il fascino eterno della Sicilia più autentica. Nel cammino non si può non notare il Duomo di San Nicola di Bari, che si apre sulla piazzetta dell’eccentrico Bar Turrisi, ed una serie di stradine che si affacciano sulle colline circostanti, sul mare, sull’Etna.





I castelmolesi (o molesi) sono ben orgogliosi di far subito presente che il loro paese è la patria del vino alla mandorla, che può essere degustato praticamente ovunque in paese, ad esempio nel Bar San Giorgio di don Vincenzo Blandano (che ha il vanto di essere l’inventore di questo vino liquoroso dal sapore così aromatico, ed accadde “per caso”, quando buttò delle mandorle a macerare nel mosto durante la produzione del suo vino). Ci fermiamo in un baretto subito dietro Piazza Sant’Antonio, dove il babbo si mangia un arancino (dichiarerà “il più buono mai mangiato in tutta la Sicilia”) e noi prendiamo una granita. I nostri compagni di viaggio lasciano un rene per l’acquisto di alcune bottiglie di vino alla mandorla, ma mi lascio tentare anche io. Il simpatico barista ci tiene a precisare che “questo vino va a male solo quando finisce”, e che va servito freddo con una scorzetta di arancia e può essere usato ovunque.

 Alle 13:30 siamo alla biglietteria del Teatro Greco (ingresso 10,00 €).
Alle 13:30 siamo alla biglietteria del Teatro Greco (ingresso 10,00 €). Grandiosa testimonianza della Sicilia Antica, il Teatro Greco è il monumento più famoso di Taormina, e il secondo teatro più grande dell’isola dopo quello di Siracusa. Edificato dai greci nel III Secolo a.C. (che scelsero lo scenografico promontorio come ambientazione per le loro rappresentazioni drammatiche e musicali) il Teatro nel II secolo d.C. fu modificato e ampliato dai romani che lo trasformarono in un’arena dove avevano luogo i combattimenti tra i gladiatori e gli spettacoli di caccia. La scena è la parte più importante che rimane del Teatro e conserva, in parte, la sua forma originale. Nulla invece rimane dei suoi ornamenti e delle colonne. Si dice che queste arrivarono via mare, furono poi agganciate con funi e tirate da orde di schiavi fino al Teatro. Durante il medioevo gran parte di queste colonne vennero asportate per costruire palazzi ed abbellire luoghi di culto, tra cui la Cattedrale.
 La cavea è tutta scavata nella roccia, seguendo la naturale concavità della collina, parte dal basso e sale fino alla sommità, e poteva contenere fino a 5400 spettatori. I gradini erano distinti in due parti; nell'una sedevano gli spettatori, che potevano anche servirsi di cuscino; nell'altra metà, leggermente incavata, poggiavano i piedi coloro che sedevano sul gradino superiore. I primi posti erano sicuramente riservati alle autorità.
Dall’alto della capiente cavea si gode il magnifico panorama della costa calabra e della costa ionica siciliana con l’Etna sullo sfondo. Sospesa tra mare e cielo, questa meravigliosa opera architettonica dall’acustica perfetta, ospita da diversi anni oramai concerti e manifestazioni culturali estive. Decisamente bello, e la posizione favolosa lo avvantaggia.
La cavea è tutta scavata nella roccia, seguendo la naturale concavità della collina, parte dal basso e sale fino alla sommità, e poteva contenere fino a 5400 spettatori. I gradini erano distinti in due parti; nell'una sedevano gli spettatori, che potevano anche servirsi di cuscino; nell'altra metà, leggermente incavata, poggiavano i piedi coloro che sedevano sul gradino superiore. I primi posti erano sicuramente riservati alle autorità.
Dall’alto della capiente cavea si gode il magnifico panorama della costa calabra e della costa ionica siciliana con l’Etna sullo sfondo. Sospesa tra mare e cielo, questa meravigliosa opera architettonica dall’acustica perfetta, ospita da diversi anni oramai concerti e manifestazioni culturali estive. Decisamente bello, e la posizione favolosa lo avvantaggia.
 La Sicilia ha tanto di tutto, millenni di storia, un mix di architetture provenienti dai vari domini che si sono susseguiti nel corso dei secoli, acque turchesi, gente ospitale e buon cibo. Peccato soltanto l’incuria, la sporcizia a volte, appena si esca fuori dai sentieri più turistici (e questo, con un viaggio itinerante diventa evidentissimo)… e la guida “spericolata”: ti tagliano la strada, parcheggiano in tripla fila, non guardano nemmeno quando escono da una strada secondaria per prendere la principale. Insomma, diciamo che guidare in Sicilia è stato peggio che nelle stradine di Zante o nelle single tracks del Regno Unito!
La Sicilia ha tanto di tutto, millenni di storia, un mix di architetture provenienti dai vari domini che si sono susseguiti nel corso dei secoli, acque turchesi, gente ospitale e buon cibo. Peccato soltanto l’incuria, la sporcizia a volte, appena si esca fuori dai sentieri più turistici (e questo, con un viaggio itinerante diventa evidentissimo)… e la guida “spericolata”: ti tagliano la strada, parcheggiano in tripla fila, non guardano nemmeno quando escono da una strada secondaria per prendere la principale. Insomma, diciamo che guidare in Sicilia è stato peggio che nelle stradine di Zante o nelle single tracks del Regno Unito!A questo punto, fuori dal Teatro Greco lascio i miei e gli altri e prendo la funivia per scendere sulla costa. Con un biglietto da 3,00 € ho diritto a cinque minuti di ansia appesa alla cabina, ma ne vale la pena! Poco oltre la stazione di arrivo della funivia (che per l’esattezza è Mazzarò), sulla sinistra si apre una scalinata di ben 135 gradini, chiusa tra due pareti addobbate con vestitini di cotone e pareo da mare: in fondo alle scale, un isolotto ricco di rigogliosa vegetazione unito alla terraferma da una sottile striscia di sabbia, che nel tratto centrale, il succedersi delle maree, fa affiorare o lascia coperta dalle acque cristalline della baia.

 Questa suggestiva propaggine di terra, situata nell’incantevole insenatura dopo il promontorio di Sant’Andrea, è Isola Bella. Riserva naturale dal 1998, la bella “perla del Mediterraneo”, decantata da poeti e scrittori di tutta Europa, si articola in piccoli terrazzamenti collegati da scalette e camminamenti, immersi nel verde di una fitta macchia mediterranea e affascinanti arbusti esotici (con un biglietto d’ingresso di 4,00 € - non entro a visitarla perché non ho troppo tempo, ma sembrerebbe valerne la pena!). Nel 1984 è stata dichiarata bene di rilevante interesse storico-artistico e, finalmente, nel 1990 la Regione Sicilia è riuscita a tornarne in possesso acquistandola.
Questa suggestiva propaggine di terra, situata nell’incantevole insenatura dopo il promontorio di Sant’Andrea, è Isola Bella. Riserva naturale dal 1998, la bella “perla del Mediterraneo”, decantata da poeti e scrittori di tutta Europa, si articola in piccoli terrazzamenti collegati da scalette e camminamenti, immersi nel verde di una fitta macchia mediterranea e affascinanti arbusti esotici (con un biglietto d’ingresso di 4,00 € - non entro a visitarla perché non ho troppo tempo, ma sembrerebbe valerne la pena!). Nel 1984 è stata dichiarata bene di rilevante interesse storico-artistico e, finalmente, nel 1990 la Regione Sicilia è riuscita a tornarne in possesso acquistandola.
 Cammino sulla spiaggia a piedi nudi (avviso che ci sono sassi grossi come limoni, che diventano più sottili e meno fastidiosi solo sulla riva), l’acqua è trasparente. Attraverso la sottile linguetta di sabbia, con i piedi in ammollo raggiungo l’isolotto per avere un diverso punto di vista sulla baia. Adesso capisco perché questo posto è così ricercato!
Decido di risalire in centro attraverso la lunghissima scalinata che collega Isola Bella alle vie di Taormina. I gradini sono tanti, tantissimi, infiniti. Lungo la salita, il Belvedere Luigi Pirandello offre uno scorcio meraviglioso e nitido sul Golfo di Sant’Andrea, con Isola Bella nel mezzo e la sua moltitudine di piccole rocce tutte attorno. La più bella vista sulla spiaggia è sicuramente questa, e ripaga della fatica della lunga scalinata.
Cammino sulla spiaggia a piedi nudi (avviso che ci sono sassi grossi come limoni, che diventano più sottili e meno fastidiosi solo sulla riva), l’acqua è trasparente. Attraverso la sottile linguetta di sabbia, con i piedi in ammollo raggiungo l’isolotto per avere un diverso punto di vista sulla baia. Adesso capisco perché questo posto è così ricercato!
Decido di risalire in centro attraverso la lunghissima scalinata che collega Isola Bella alle vie di Taormina. I gradini sono tanti, tantissimi, infiniti. Lungo la salita, il Belvedere Luigi Pirandello offre uno scorcio meraviglioso e nitido sul Golfo di Sant’Andrea, con Isola Bella nel mezzo e la sua moltitudine di piccole rocce tutte attorno. La più bella vista sulla spiaggia è sicuramente questa, e ripaga della fatica della lunga scalinata.

 Duecento metri oltre il belvedere, l’ingresso ai Giardini Pubblici intitolati al duca di Cesarò: originariamente erano un parco privato nato per volontà di Lady Florence Trevelyan Cacciola, la nobildonna scozzese che visse a Taormina dal 1884 e ne sposò l’allora sindaco. Realizzato come un tipico giardino all’inglese, il parco fu riempito di una grande varietà di fiori e piante provenienti da tutto il mondo ma anche di singolari edifici dal gusto esotico che richiamano lo stile bizantino, utilizzati da Lady Florence, appassionata ornitologa, per osservare gli uccelli. La costruzione più caratteristica è la cosiddetta “The Beehives”, fantasioso padiglione che ricorda, come dice il nome, un alveare. Meritava una visita!
Duecento metri oltre il belvedere, l’ingresso ai Giardini Pubblici intitolati al duca di Cesarò: originariamente erano un parco privato nato per volontà di Lady Florence Trevelyan Cacciola, la nobildonna scozzese che visse a Taormina dal 1884 e ne sposò l’allora sindaco. Realizzato come un tipico giardino all’inglese, il parco fu riempito di una grande varietà di fiori e piante provenienti da tutto il mondo ma anche di singolari edifici dal gusto esotico che richiamano lo stile bizantino, utilizzati da Lady Florence, appassionata ornitologa, per osservare gli uccelli. La costruzione più caratteristica è la cosiddetta “The Beehives”, fantasioso padiglione che ricorda, come dice il nome, un alveare. Meritava una visita!
 Da lì torno indietro al belvedere e proseguo poco oltre fino al terminal dei bus. Si sta facendo buio, con 1,90 € prendo un biglietto che mi porta alla fermata Recanati-Giardini Naxos. In breve, una volta scesa dal bus, torno al camper.
Da lì torno indietro al belvedere e proseguo poco oltre fino al terminal dei bus. Si sta facendo buio, con 1,90 € prendo un biglietto che mi porta alla fermata Recanati-Giardini Naxos. In breve, una volta scesa dal bus, torno al camper.Martedì 27 ottobre – km 109575
da Giardini Naxos a Morano Calabro (km 347)
 Oggi è nuvoloso. Anzi, poco dopo essere usciti dall’area sosta, in prossimità del centro commerciale I Gabbiani, inizia anche a piovere. Ci infiliamo per qualche ultimo acquisto di prodotti locali (il supermercato è molto fornito) e poi tiriamo dritto in autostrada verso Messina. Arriviamo e parcheggiamo abbastanza agevolmente nel parcheggio della Casa di Cura Cristo Re, a duecento metri dal Sacrario del Cristo Re, la prima cosa che riusciamo a vedere con un cielo scuro che minaccia pioggia. L’aria è molto fredda, in compenso almeno il panorama dalla terrazza è bello: a parte gli edifici classici da città portuale, il porto è abbastanza raccolto e dall’alto è anche grazioso: spicca la Madonnina della Lettera, simbolo di indissolubile legame tra Messina e il mare. E’ una statua in bronzo dorato posta in cima ad una stele votiva (altezza totale 60 metri) all’estremità del braccio di San Raineri, punto in cui le navi entrano ed escono dal porto.
Oggi è nuvoloso. Anzi, poco dopo essere usciti dall’area sosta, in prossimità del centro commerciale I Gabbiani, inizia anche a piovere. Ci infiliamo per qualche ultimo acquisto di prodotti locali (il supermercato è molto fornito) e poi tiriamo dritto in autostrada verso Messina. Arriviamo e parcheggiamo abbastanza agevolmente nel parcheggio della Casa di Cura Cristo Re, a duecento metri dal Sacrario del Cristo Re, la prima cosa che riusciamo a vedere con un cielo scuro che minaccia pioggia. L’aria è molto fredda, in compenso almeno il panorama dalla terrazza è bello: a parte gli edifici classici da città portuale, il porto è abbastanza raccolto e dall’alto è anche grazioso: spicca la Madonnina della Lettera, simbolo di indissolubile legame tra Messina e il mare. E’ una statua in bronzo dorato posta in cima ad una stele votiva (altezza totale 60 metri) all’estremità del braccio di San Raineri, punto in cui le navi entrano ed escono dal porto.
 Raggiungiamo Piazza Duomo, ad un chilometro di distanza,, e ci troviamo di fronte l'omonimo luogo di culto della città.
Risale al 1120 e fu costruito per volere del re normanno Ruggero II. Più volte distrutto da incendi (terribile l'ultimo, quello del 1943, per le bombe degli alleati) e terremoti, è sempre stato ricostruito conservando nelle linee architettoniche l'antica struttura normanna.
Raggiungiamo Piazza Duomo, ad un chilometro di distanza,, e ci troviamo di fronte l'omonimo luogo di culto della città.
Risale al 1120 e fu costruito per volere del re normanno Ruggero II. Più volte distrutto da incendi (terribile l'ultimo, quello del 1943, per le bombe degli alleati) e terremoti, è sempre stato ricostruito conservando nelle linee architettoniche l'antica struttura normanna.


 Piove così tanto che siamo costretti a chiamare un taxi per tornare al camper, benché la strada non sia molta: è l’incertezza sulla pioggia che ci fa desistere dall’aspettare! Guarda caso, poco dopo essere rientrati con i piedi in ammollo nelle scarpe, spiove.
Dopo pranso lasciamo 4,00 € all’omino del parcheggio, nonostante avesse inizialmente detto che la tariffa era di 0,80 centesimi l’ora… ma vabè, qui si aggiustano tutti i prezzi come vogliono.
Piove così tanto che siamo costretti a chiamare un taxi per tornare al camper, benché la strada non sia molta: è l’incertezza sulla pioggia che ci fa desistere dall’aspettare! Guarda caso, poco dopo essere rientrati con i piedi in ammollo nelle scarpe, spiove.
Dopo pranso lasciamo 4,00 € all’omino del parcheggio, nonostante avesse inizialmente detto che la tariffa era di 0,80 centesimi l’ora… ma vabè, qui si aggiustano tutti i prezzi come vogliono.  Poco dopo, superata Messina, arriviamo a Capo Piloro, una delle tre punte della Sicilia. Siamo nel punto “più stretto dello stretto”, dove la Sicilia si avvicina alla Calabria e dove la geografia smette di essere astrazione e si fa concreta. Dicono che nelle giornate limpide sia addirittura possibile, da qui, vedere la costa viola e le macchine che passano sull’autostrada. Ovviamente oggi non è quella giornata. Il cielo è nero e l’enorme pilone Punta Faro (in dialetto messinese “u piluni”), dall’alto dei suoi 225 metri, la fa da padrone immerso nella nebbia. Si tratta di un traliccio dell’alta tensione (ce n’è uno identico dalla parte della Calabria, che però ha un basamento di altezza superiore per via dei rilievi calabri), costruito nel 1955 e ormai in disuso.
Torniamo in città e perdiamo mezz’ora per entrare all’imbarco: le indicazioni stradali fanno schifo, ma peggio delle indicazioni stradali c’è la strada stessa, che dà accesso agli imbarchi da una sola direzione senza possibilità di errore (altrimenti bisogna percorrere chilometri per invertire il senso di marcia). Il vantaggio è che saliamo praticamente al volo, con il biglietto alla mano. Poco dopo, ecco che la Sicilia diventa già un ricordo che sbiadisce nella fitta nebbia autunnale e la Salerno-Reggio Calabria ci dà il bentornati in “continente”. Viaggiamo ben oltre il buio e ci fermiamo a Morano Calabro presso un’area comunale tranquilla e pulita, con ottime recensioni e con una bella vista sul paesino. Che, guarda caso, è uno dei Borghi più belli d’Italia!
Stasera, però, si dorme con pigiama e calzettoni pesanti.
Poco dopo, superata Messina, arriviamo a Capo Piloro, una delle tre punte della Sicilia. Siamo nel punto “più stretto dello stretto”, dove la Sicilia si avvicina alla Calabria e dove la geografia smette di essere astrazione e si fa concreta. Dicono che nelle giornate limpide sia addirittura possibile, da qui, vedere la costa viola e le macchine che passano sull’autostrada. Ovviamente oggi non è quella giornata. Il cielo è nero e l’enorme pilone Punta Faro (in dialetto messinese “u piluni”), dall’alto dei suoi 225 metri, la fa da padrone immerso nella nebbia. Si tratta di un traliccio dell’alta tensione (ce n’è uno identico dalla parte della Calabria, che però ha un basamento di altezza superiore per via dei rilievi calabri), costruito nel 1955 e ormai in disuso.
Torniamo in città e perdiamo mezz’ora per entrare all’imbarco: le indicazioni stradali fanno schifo, ma peggio delle indicazioni stradali c’è la strada stessa, che dà accesso agli imbarchi da una sola direzione senza possibilità di errore (altrimenti bisogna percorrere chilometri per invertire il senso di marcia). Il vantaggio è che saliamo praticamente al volo, con il biglietto alla mano. Poco dopo, ecco che la Sicilia diventa già un ricordo che sbiadisce nella fitta nebbia autunnale e la Salerno-Reggio Calabria ci dà il bentornati in “continente”. Viaggiamo ben oltre il buio e ci fermiamo a Morano Calabro presso un’area comunale tranquilla e pulita, con ottime recensioni e con una bella vista sul paesino. Che, guarda caso, è uno dei Borghi più belli d’Italia!
Stasera, però, si dorme con pigiama e calzettoni pesanti.Mercoledì 28 ottobre – km 109922
da Morano Calabro a Porto Sant’Elpidio (580 km)
 Stamattina, colazione con l’ultima cassatina siciliana e poi si parte, anche un po’ prima del solito: ovviamente resto in pigiama, poiché la giornata è interamente dedicata alla trasferta, l’ultima lunghissima tappa di circa 580 chilometri che ci restano per arrivare praticamente a casa.
Nei pressi dell’area di servizio di Sala Consilina, prima che le strade si dividano, salutiamo i nostri compagni di viaggio Vito e Luciana (Guido e Loriana, per il babbo che ha spesso cambiato i loro nomi!), persone disponibili, collaborative e socievoli.
Stamattina, colazione con l’ultima cassatina siciliana e poi si parte, anche un po’ prima del solito: ovviamente resto in pigiama, poiché la giornata è interamente dedicata alla trasferta, l’ultima lunghissima tappa di circa 580 chilometri che ci restano per arrivare praticamente a casa.
Nei pressi dell’area di servizio di Sala Consilina, prima che le strade si dividano, salutiamo i nostri compagni di viaggio Vito e Luciana (Guido e Loriana, per il babbo che ha spesso cambiato i loro nomi!), persone disponibili, collaborative e socievoli. Arriveremo in zona costa marchigiana intorno alle 18, mentre Vito e Luciana arriveranno a Bordighera a mezzanotte, dopo un lunghissimo e coraggioso viaggio (percorreranno praticamente da sud a nord tutto lo stivale!).
Mercurio dorme praticamente h24. La giornata scorre pigra anche per me e, fondamentalmente, tutta uguale, sotto un cielo che già annuncia autunno. Quello che, fino all’altro ieri, nella terra del sole non avevamo ancora preso in considerazione.
“L'Italia senza la Sicilia, non lascia nello spirito immagine alcuna. È in Sicilia che si trova la chiave di tutto […] La purezza dei contorni, la morbidezza di ogni cosa, la cedevole scambievolezza delle tinte, l'unità armonica del cielo col mare e del mare con la terra… chi li ha visti una sola volta, li possederà per tutta la vita”
— Johann Wolfgang von Goethe
Clicca qui per visualizzare l'itinerario!